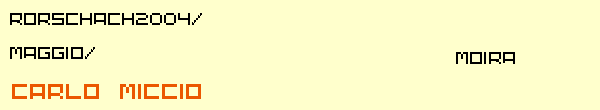| |
Ieri il mio vicino di casa si è suicidato.
Si chiamava Marco Cicoli, era un medico, e nessuno veramente sa perché
l'abbia fatto. Si è imbottito di pillole ed è morto, seduto
in poltrona con accanto una bottiglia di vodka mezza vuota. Ho sentito due
poliziotti che parlavano sul pianerottolo, e dicevano che il cadavere, visto
attraverso la bottiglia di vodka mezza vuota, sembrava la cover sbiadita di
una pubblicità della Smirnoff.
Io il dottor Cicoli lo conoscevo appena: viveva qui da circa otto mesi, con
lui vedevo a volte una donna entrare ed uscire di casa agli orari più
diversi. Ci avevo scambiato si e no una decina di buongiorni e buonesere,
convenevoli da ascensore, fino a quella sera delle chiavi.
Circa un mesetto fa, tornando a casa, l'ho incontrato seduto fuori al pianerottolo,
addosso solo una canottiera, un paio di calzoncini da calcio, e le ciabatte
ai piedi. Faceva un caldo boia quel giorno, e lui era rimasto chiuso fuori
di casa mentre usciva a spostare la spazzatura. Gli chiesi se avesse un altro
paio di chiavi, e mi rispose che lui no, ma Teresa ne aveva una copia e sarebbe
tornata in un paio d'ore.
Lo invitai dentro, e lui mi seguì ringraziando.
Ci sedemmo in cucina e misi su un caffè: intanto lui mi spiegava che
era un medico, veniva da una città del nord ed era in servizio alla
Usl locale solo da pochi mesi. Teresa non era sua moglie, ma non mi spiegò
neanche chi fosse. All'inizio chiacchierammo del più e del meno, del
tempo giù da noi, del condominio, di quello strano carciofone illuminato
che avevano installato alle porte della città, e così via. Poi,
dopo un po', Teresa non si vedeva ed io proposi un ammazzacaffè, e
quella si rivelò la svolta del match, come direbbero alla Domenica
Sportiva: il dottor Cicoli spalancò gli occhi acconsentendo lieto,
e dopo circa un quarto d'ora si era già scolato tre cicchetti di grappa
al mirtillo e uno alla pera. Conoscevo quello sguardo, conoscevo quelle intenzioni,
il dottor Cicoli sembrava appartenere a quella numerosa categoria di individui
che perde ogni controllo e raziocinio se posti davanti ad una bottiglia di
qualsiasi bevanda alcolica.
Alcolista, più o meno dottore, più o meno anonimo, ma in ogni
caso un alcolista.
L'atmosfera iniziò a sfilacciarsi sull'intimo, vide la foto di me,
Laura e Mauro a Venezia, e mi chiese chi fossero ("Mio figlio e la
mia ex moglie" sussurrai diligente) e la riposò lesto appena
gli risposi. Parlammo di donne brevemente, nella superficiale maniera che
si usa tra uomini, e poi iniziò a raccontarmi di se. Farfugliando,
si rimboccava il bicchiere e mi raccontava del suo lavoro di medico: una volta
avevo letto una volta in un romanzo che chi fa il medico è congenitamente
una persona buona, uno che vuol far del bene all'umanità, e lui sembrava
aderire appieno all'identikit; però d'altro canto dalla sua sembrava
avere un innato senso di inadeguatezza che gli faceva venir meno proprio quella
che io, personalmente, ritenevo una qualità importante per un buon
medico: l'autorità scientifica, la convinzione della ragione, la capacità
di penetrare attraverso i dubbi di mille pazienti diversi alle prese con centomila
terapie differenti per convincere ognuno di essi sulla giusta soluzione. Marco
Cicoli sembrava piuttosto scontento di suo per riuscire ad intervenire concretamente
nelle scelte degli altri, a parer mio, anche se dubitavo andasse al lavoro
con tutta quella grappa in corpo al mattino. O forse si, andava a lavorare
ubriaco…..
Gli chiesi se gli piacesse quel lavoro (io faccio il grafico in tipografia,
un medico non me l'immagino proprio al lavoro) e lui mi disse che veramente
era un'altra la professione che lui avrebbe sempre voluto fare. A Cicoli piaceva
scrivere, avrebbe voluto vivere di quello, sentiva di avere un sacco di cose
da dire e storie da raccontare, ma non conosceva nessuno disposto a pagare
per avere quelle storie pubblicate. Suo padre era stato un cardiologo famoso,
e arrivati al dunque gli aveva precluso qualunque altra carriera professionale
che non fosse stata la medicina. Lui, Cicoli junior, da parte sua si era laureato
in medicina, e anche specializzato, dopo dodici faticosissimi anni, ma poi
alla fine decise di rimanere a lavorare alla Usl, semplice medico della mutua,
vicino alla gente. La gente, quella gente che veniva ogni giorno a trovarlo
e a parlargli dei loro problemi fisici, rivelandosi talvolta nella più
indifesa delle intimità, era come se gli iniettasse dentro tante storie
che poi continuavano a vivere di vita propria nella sua mente…la gente,
quella gente, cosi viva e malata, la gente vera, una volta tornato a casa
diventava materiale per mille racconti che poi lui non si decideva mai a spedire
a nessun editore. Questo mi stava raccontando Marco Cicoli, quando sentimmo
le chiavi infilarsi nella toppa del suo appartamento, e capimmo che Teresa
era tornata.
Da allora niente più, ci saremo incrociati un paio di volte e poi basta.
Ieri
mattina l'ho visto uscire, con una serie di buste da lettera in mano, compilate
ed affrancate. Mi sembrava come in ipnosi, è uscito di corsa dal suo
appartamento, e mi ha salutato di fretta. Poi ho sentito che rientrava dopo
una decina di minuti, e poi non ho sentito più nulla. Alle otto di
ieri sera è tornata Teresa, un urlo strozzato in gola, e dopo 5 minuti
è arrivata l'ambulanza. Il dottor Marco Cicoli si era ammazzato, e
nessuno sapeva perché.
Poi stamattina mi è arrivata questa lettera, e ho visto che il mittente
era lui, e allora ho riconosciuto la busta come una delle tante che aveva
in mano l'ultima volta che lo vidi. L'ho aperta veloce, e dentro ci ho trovato
un racconto. Il suo ultimo gesto era stato quello di imbustare i suoi cento
racconti mai letti e spedirli a chissà chi, amicizie casuali e conoscenze
fortuite, come me. Mi ritenni in un certo senso fortunato, e iniziai a leggere
il racconto che aveva deciso di spedire a me.
Si intitolava "Le Ultime parole di Moira Colcic".
Conosco Moira Colcic da almeno trent'anni,
da quando la sua famiglia è arrivata in città dalla Bulgaria.
Era una bambina svelta ed allegra, e generalmente sana. Suo padre è
morto d' infarto quando lei aveva tredici anni, e la madre è rimasta
sola con lei e i suoi quattro fratelli maschi. Moira iniziò a combinarne
di cotte e di crude, e per un po' si è gingillata con l'eroina: un
destino comune a molti di quella generazione, e lei, come pochi fortunati,
ci è entrata presto (15 anni? 16 anni?) e presto ne è uscita.
L'ho vista e aiutata spesso in quel periodo: farmaci prima, poi gli ho segnalato
una buona psicologa. Voleva smettere, si capiva, ed infatti ci è riuscita,
completamente pulita senza ricadute alcune dall'età di anni 25. Unico
ostinato souvenir di quegli anni selvaggi: il virus dell'epatite C cronicamente
impiantato nel suo fegato.
Moira intraprese una vita tranquilla: aveva trovato un lavoro alla Coin e
si era sposata con un ragazzo tranquillo. La rividi quando le nacque il bambino,
Mattia, e poi poche altre volte, soprattutto per il bambino. Lei stava bene,
ma era consapevole di avere una specie di bomba ad orologeria impiantata nel
fegato, e si sottoponeva a regolari controlli.
Andò tutto bene fino a dopo i quaranta, poi le transaminasi iniziarono
a sbollire e il carico virale le era diventato una specie una specie di indice
di borsa, su e giù, su e giù.
Insieme decidemmo di tentare l'inteferone, e la spedii in ospedale per fare
dei cicli, ma esce fuori che non lo tollera e dopo tre sedute dobbiamo smettere.
Moira continuava a peggiorare, era parecchio dimagrita anche, e un po' depressa
al pensiero di una possibile morte, e soprattutto, all'idea di dover lasciare
solo al mondo il suo bambino, perché il padre era un farabutto incapace,
sempre secondo lei. La spedii la settimana scorsa per farsi nuovi test, e
mi è tornata oggi in studio con questi foglietti accartocciati in mano.
"Allora?" mi chiede dopo aver aspettato che leggessi tutti i dati.
Respiro forte, e le dico che mi dispiace davvero, ma sembra che l'unica via
d'uscita possibile sia il trapianto.
Avete mai guardato in faccia una persona a cui state suggerendo un trapianto?
Cuore, fegato, rene, non importa: un trapianto, l'espressione di qualcuno
che deve sostituire porzioni del proprio corpo, come si fa con le macchine
dal meccanico. Valvole, organi, pistoni: per noi medici è più
facile parlare così, ci si fa capire, ma provate voi ad entrare nella
mente di qualcuno a cui hanno appena detto che il suo fegato è definitivamente,
ineluttabilmente compromesso, e che per sopravvivere deve attendere che qualcuno
muoia, possibilmente all'improvviso e nelle vicinanze.
Moira sapeva di questa possibilità da quando era risultata positiva
28 anni prima, ma sapete com'è…tutti sappiamo di dover morire
un giorno, ma quanti arrivano preparati a quel momento?
E in più Moira non voleva morire, non ne aveva né voglia né
tempo, aveva da fare, aveva un figlio a cui badare.
Però c'era un però, come sempre: ed il però in questione
si chiamava "Liste di attesa": non era semplice, ne sicuramente
veloce ottenere un fegato funzionante e compatibile, e Moira Colcic non aveva
tantissimo tempo a disposizione: quel virus di merda aveva atteso quasi una
trentina d'anni prima di mettersi in moto, ma quando finalmente si era deciso
l'aveva fatto con una velocità impressionante, irradiando di cirrosi
ogni cellula epatica. Un cancro non è mica qualcosa che ti debilita
le cellule: al contrario, te le moltiplica esponenzialmente, è un corto
circuito di iperfunzionalità, fino a che non ce la fa più ad
essere contenuto nell'involucro e ti esplode dentro. Donatori sani, tra l'altro,
parlando di un organo così delicato, non abbondano certo. L'ipotesi
più veloce, e tecnicamente più sicura, rimaneva l'innesto suino.
Quando glielo spiegai a Moira, per un attimo sicuramente lei non mi credette,
pensò che non fossi serio, però è vero, le cellule staminali
del fegato dei maiali sono perfettamente compatibili con quelle umane, ed
è una soluzione pratica ed efficace. Appositi esemplari sono allevati
su una dieta sanissima per queste eventualità, fisicamente non ci sono
grandi problemi di rigetto, psicologicamente invece………non è
sempre semplice accettare di essere parzialmente animali.
E Moira era decisamente una di questi, perché la sua espressione cambia
radicalmente, ed inizia a guardarmi sdegnata:
"A dottò-ma che cazzo stai a ddì? Io c'ho la cancrena e
tu mi pigli per il culo?" Moira Colcic era una donna del popolo, e come
il popolo parlava senza veli alcuni: era convinta che io la stessi prendendo
in giro in un momento così drammatico.
Cerco di tranquillizzarla, provo a buttarla sullo scherzo, le parlo delle
Sirene, mezze donne mezze pesci, che la vita è sempre la cosa più
importante, e che non c'era niente di male a contaminarsi e che… ma Moira
non voleva saperne: mi guarda in cagnesco dalla sua sedia, e sembra sempre
più sul punto di esplodere, mentre continuo ad elencare prove scientifiche
e dati ministeriali sull'efficacia del trapianto da cellule suine, finchè
ad un certo punto Moira Colcic non ce la fa più a trattenersi: salta
su in piedi e di scatto mi agguanta per il colletto
"Ah dottò, ma che cazzo stai a di'??? Né sirena né
maiala…donna intera sono nata e donna intera c'ho da morì!".
Dopodiché mi ha mollato d'improvviso e facendo un passo indietro ha
sferrato un calcione alla mia scrivania, che mi si è rovesciata addosso
in un turbinio di foglietti e ricettari: mentre cascavo per terra sentivo
uno sputo arrivarmi diritto in faccia, e la voce di Moira che si allontanava
urlando:
"Ah dottò, mavaffanculovà".
Non la rividi mai più, e quelle rimasero le ultime parole di Moira
Colcic che io abbia mai sentito.
|
|