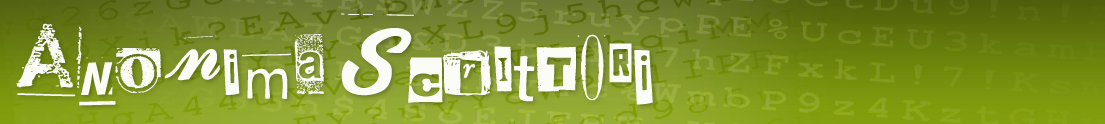PRATOLINI FASCIOCOMUNISTA?
Sta per uscire la nuova edizione Rizzoli-Bur di Metello di Vasco Pratolini, con la prefazione dell'umile sottoscritto. Il Corriere della Sera di oggi (lunedì 18 aprile 2011) ne ha data una corposa anticipazione, che per forza di cose era però limitata alle sole questioni diciamo ideologico-politiche - i cosiddetti "redenti" e il fasciocomunismo - che per loro erano evidentemente le più chiassose. Io in realtà di queste cose è da tempo oramai che scrivo e non mi paiono poi d'assoluta novità. Credo invece che le cose più importanti che mi sia riuscito di mettere in questa prefazione siano quelle più specificatamente di critica letteraria, ed è di queste che sono più contento, essendo cose "nuove" che prima non avevo ancora detto. Ve la posto tutta, quindi, e vediamo il giudizio vostro e dei lettori.
DALLA PARTE DI METELLO
di a.pennacchi
Metello è un classico e la cosa più saggia sarebbe saltare a piè pari ogni Introduzione e mettersi a leggere direttamente il libro. Dice: “E tu perché l’hai scritta?”. Perché me l’hanno chiesta e perché pare che così si usi: ogni volta che si ristampa un classico, lo si fa precedere da una introduzione che spieghi al lettore perché è un classico e perché, quindi, è ancora attuale. Un classico difatti è un libro che non parla solo ai tempi suoi di quando è stato scritto, ma parla a tutti i tempi poiché la gente – leggendo pure i fatti di quei tempi là – ci ritrova lo stesso parco delle emozioni e sentimenti suoi di questi tempi qua. Ci si ritrova. Nello stesso e identico modo di sentirsi nel mondo. Di gioire, di amare, di odiare o di soffrire.
E’ chiaro però che il libro deve essere fatto bene, perché scattino questi meccanismi di identificazione. Non è che succeda con tutti i libri. Mica tutti diventano classici. Solo alcuni. E questi si ristampano e ripubblicano, e ci si mette pure l’Introduzione anche se non servirebbe, perché – se sono appunto classici – la gente lo capisce da sola, man mano che li legge, che parlano ancora e prepotentemente pure ai tempi e ai sentimenti suoi.
Metello quindi è un classico che parla da solo al lettore. Anzi, più che classico è proprio di un’attualità impressionante. Narra di cose avvenute più di cent’anni fa – alla fine dell’Ottocento, a Firenze, ai primi albori del socialismo e del movimento operaio nel suo lungo cammino verso l’emancipazione – ma che continuano ad avvenire, e nella stessa modalità, tutti i giorni e in ogni parte del mondo. C’è la gente che cade e muore dai cantieri edili in Metello, mentre si costruiscono i primi palazzi e quartieri nuovi al di là dell’Arno. Ma c’è la gente che continua a cadere e morire sul lavoro ogni giorno in Italia e nel mondo. Quattro al giorno ogni giorno in Italia. E c’è la gente – i lavoratori – che provano a stringersi ed unirsi l’uno all’altro per ottenere migliori e più sicure condizioni di lavoro, per ottenere il lavoro stesso, per uscire dalla miseria e dal bisogno, per “emanciparsi”, come si diceva una volta. E le conquiste ottenute – le poche conquiste – sembrano chissà che cosa: “Mai più ce le toglieranno”. E invece ogni generazione sembra condannata a doversi rifare ogni volta il suo proprio cammino di avanzamento e progresso. Come può non parlare Metello – il muratore Metello Salani del 1894 – al giovane precario di oggi, sempre sottoposto al ricatto dei contratti a tempo? E oggi come allora non rischia il biasimo e l’isolamento generale chiunque provi, invece, a lottare ancora per i diritti sindacali di tutti? “Ringrazia il padrone che ti dà da mangiare”. Non è il padrone – il capitale – che fa i soldi sul lavoro e le ristrettezze mie, ma sono io che dovrei essere grato a lui per la sua bravura e le opportunità che benevolmente mi dà.
Ora è chiaro che non c’è solo questo in Metello – e soprattutto detto in questo modo – se no sarebbe un pappone sociologico, un mattone sullo stomaco. Invece è un bel romanzo, divertente, appassionante, perché l’etica del lavoro, il bene e il male, la soddisfazione di chi si riconosce nel proprio lavoro quando è fatto bene non sono spiegate o declamate, ma emergono dalla pura narrazione delle storie e delle avventure di Metello Salani e dei suoi compagni, delle loro donne, dei loro drammi, dei tradimenti, la prigione, gli amori, gli spari dei soldati e della polizia.
Anzi, l’eroe vero, se si guardano bene le pagine in controluce, non è Metello in tutto il suo percorso da piccolo orfano a muratore provetto, da adolescente che scopre l’amore con una donna più grande (è il mito della “nave scuola” che si ripropone eterno, il topos etnico ed il sogno ancestrale dei giovani maschi italici, ma non solo, d’ogni era. Chissà se dietro c’è Edipo e Giocasta) fino al suo ritrovarsi – dall’uomo né meglio né peggio, “uno come tutti gli altri”, che avrebbe voluto essere – leader e capo riconosciuto dei suoi compagni. Ed anche in questo – nella solitudine del leader, nelle incertezze e le paure che prima deve governare, reprimere e superare dentro di sé, per poter dare poi sicurezza agli altri e condurli compatti alla lotta e alla vittoria – sta l’eterna modernità di questo romanzo. Quelle lotte, quei leader e quegli eroi sono cominciati con Spartaco – anzi, con Prometeo, perlomeno – continuano oggi in Fiat o nei call center e proseguiranno un giorno sulle stelle e sui pianeti.
L’eroe massimo però, dicevamo, non è Metello, ma sua moglie Ersilia. E’ in lei la forza vera, nella figlia del vecchio compagno anarchico – il maestro d’arte di Metello come si diceva una volta, il mastro muratore – morto sul lavoro ai piedi d’una impalcatura. La fonte d’ogni forza è in lei, in Ersilia – la “coscienza di classe” primigenia, verrebbe da dire con i manuali d’antan non ancora epurati dal postmarxismo – che non ha mai una titubanza, una deflessione e sa cosa è bene e cosa è male, gli legge nel pensiero, sa pure perdonare. E tutte le debolezze di Metello spariscono, taumaturgate in silenzio da Ersilia.
Non ci è qui possibile però eludere il rapporto tra Pratolini e il fascismo: ora è chiaro – in termini marxiani – che Metello è tutta “coscienza di classe” ed ansia egualitaria; è coscienza di classe che si fa canto, canto epico e lirico assieme. E su questo non c’è dubbio. Come non c’è dubbio sulla partecipazione attiva di Pratolini al movimento comunista della Resistenza contro il nazifascismo a Roma, a partire dal luglio 1943. Ma rimane che la sua formazione (Vasco Pratolini nasce a Firenze nel 1913, e morirà a Roma nel 1991) avviene tutta durante il fascismo, anzi, all’interno del fascismo stesso: Pratolini scrive a pieno titolo sulle riviste fasciste e pubblica i primi libri durante e non contro il fascio. A differenza di quanto sostenuto da alcuni, si tratta di vedere se quella “coscienza di classe” che prenderà forma e corpo compiuti dopo il fascismo – in Metello, nel 1955 – era però già presente, come a noi sembra, anche negli scritti “durante” il fascismo. E’ cioè un’altra persona quella che scrive “prima”, rispetto a quell’altra che scriverà “dopo”? O è sempre la stessa, che parla – negli stessi sensi e stessi termini – degli stessi strati di popolo?
C’è un libro di Mirella Serri (I Redenti. Gli intellettuali che vissero due volte, 2005), che ha fatto dettagliatamente i conti alle tante amnesie dell’intellighenzia italiana formatasi tra le due guerre mondiali, e soprattutto alle eccessive retrodatazioni – spesso esagerate e di comodo – dei relativi passaggi di campo dal fascismo all’antifascismo. Ad esempio, da Nicodemo – il “buon fariseo” che per non farsi scoprire dai suoi, andava a sentire Gesù di nascosto – Delio Cantimori qualificò come “nicodemismo” l’atteggiamento suo e di tanti altri. Carlo Muscetta invece parlò di “dissimulazione onesta”, rifacendosi a un testo del Seicento di Torquato Accetto. Una sorta quindi di: “Stavamo nascosti, camminavamo sottotraccia ma non eravamo fascisti dentro, anzi, eravamo già nell’anima antifascisti da un pezzo”.
La realtà è che gran parte di loro continuò a collaborare fino al 1942 – ma anche 1943 – non solo con il regime più in generale o con le riviste dei Guf (Gruppi universitari fascisti), ma soprattutto a Primato, la rivista messa in piedi dal ministro Bottai e che fu non già “la fucina d’antifascismo” che qualcuno ha tentato d’accreditare, ma fu piuttosto la punta avanzata della “cultura fascista” e, più drammaticamente, una delle punte più avanzate, in sede di teorizzazione e propaganda, del razzismo italiano contro gli ebrei. La gente, con tutta probabilità, ha continuato a tirare avanti come se niente fosse, nella più completa normalità (Hannah Arendt la chiama, con il titolo d’un suo libro, “la banalità del male”), fino a che la tragedia – con la disfatta totale e i bombardieri angloamericani direttamente sulla testa – tra il 25 luglio e l’8 settembre 1943 non l’ha svegliata all’improvviso. Questi sono i fatti. Anzi, se vogliamo essere onesti, i primi a svegliarsi furono gli operai, che alla Fiat scioperarono a marzo 1943. Gli intellettuali aspettarono luglio. Ma “O di qua o di là!”, allora, dissero i più forti; mentre tanti non fecero neanche quello. E Vasco Pratolini – anche se, come Metello, voleva essere solo uno come gli altri: “Io voglio essere uguale agli altri miei simili” scrive ancora a maggio 1943 – posto davanti a sé stesso dalle circostanze oramai estreme, sceglie la Resistenza.
Secondo De Felice, “Molti dei passaggi all’antifascismo (non ci riferiamo a quelli meramente opportunistici) degli intellettuali più giovani (…) avvennero con una naturalezza che denota una notevole affinità culturale e psicologica di fondo”, che fa pensare a una assoluta “continuità tra il fascismo di prima e il loro successivo antifascismo e comunismo”. Per De Felice, non ci fu una “rottura culturale”, ma una “perdurante fedeltà a una visione del mondo e della politica”, cercata di realizzare prima “attraverso il fascismo, poi attraverso l’antifascismo e il comunismo”.
Sono le circostanze, appunto, che determinano assai spesso sia le scelte che gli accadimenti, ma la “coscienza di classe” di Pratolini evidentemente preesisteva al suo passaggio o conversione all’antifascismo e al comunismo. Non è che gli sia spuntata all’improvviso. C’era già quando era fascista e non nascosta, “dissimulata” o “nicodemizzata” poiché contraria al fascismo imperante, ma evidente e manifesta poiché consentanea al fascismo stesso. Era una coscienza di classe un po’ “fasciocomunista” diciamo, ma tutta in linea con quel “fascismo di sinistra” che vedeva non a caso le sue matrici nel socialismo rivoluzionario, e che produsse – oltre a tanti gravi e nefasti danni, insieme al fascismo tutto – pure il welfare, la modernizzazione e le bonifiche. Del resto, ci sarà pure stato un motivo se il popolo italiano – nonostante quei danni, il razzismo, le guerre e la brutalità della dittatura – continuò a tributare al fascismo così a lungo, e fino appunto a che non spuntassero i bombardieri, un consenso superiore alle percentuali bulgare.
E’ Pratolini stesso peraltro, in uno dei suoi ultimi romanzi (La costanza della ragione, 1963), a mettere in scena due suoi alter ego – due suoi “doppi”: Benito-fascista e Bruno-comunista – che alla fine convengono: “e scoprivamo di volere le medesime cose”. Il romanzo è fortemente segnato dal tema dell’ambiguità – qui, altro che introspezione psicologica però, sia benedetto ora e sempre Metello – l’ambiguità di chi bramerebbe voler dire e confessare, ma già sa che gli altri, da quell’orecchio, non ci vogliono sentire. E allora si deve adeguare. Nella Costanza della ragione – dopo i morti di Reggio Emilia del 1960, ma ben prima del Sessantotto e di ciò che avverrà dopo – si agitano e si muovono anche temi e miti dolorosamente controversi, quali la Resistenza tradita e il sogno palingenetico-rivoluzionario: “Uomini usciti puliti e caldi come il sole dalle galere e dalle montagne, dai campi di sterminio e di prigionia, reduci dalle scuole della rivoluzione e portatori di idee destinate a sommuovere il vecchio mondo, a dargli un nuovo ordine e una giustizia finalmente totale, si fecero persuadere a depositare le armi e invischiare in un gioco di oratoria che periodicamente lascia ancora al mitra, ma usato contro la loro gente, l’ultima parola”. E chi vuole capire capisce.
* * *
Ciò che più colpisce però dell’avventura di Metello, è il fatto che quando questo grande libro uscì – nel 1955 – l’accoglienza della critica fu tutt’altro che entusiasta e unanime.
Ci fu a chi piacque – pochi (Salinari su tutti) – ma ci fu soprattutto a chi non piacque. Anzi, si fecero proprio reggere, poiché quello era il tempo in cui dal neorealismo bisognava passare – secondo i critici “laureati” – al realismo o, più specificatamente, al realismo socialista. E nel realismo socialista non era assolutamente pensabile – secondo loro – che un eroe proletario si potesse scordare di una riunione, della rivoluzione o di uno sciopero perché stava con l’amante. Ma che scherziamo? “Più in camera da letto che alla Camera del lavoro?” (Muscetta). E mica si fa così un romanzo: “Metello cresce ma non muta. Non ha crisi”, disse Fortini. E per Italo Calvino non era proprio giusto – anzi, era proprio sbagliato – continuare a cantare “gli uomini medi, gli uomini senza scintille, o con scintille lontane, nascoste, remote”.
Ora lasciamo perdere che una persona di buon senso non possa non chiedersi se lo abbiano davvero letto il libro, prima di armarsi di bastone.
Le scintille – ad esempio – “lontane, nascoste e remote”? Ma ce le avessi tu, le scintille che ha in petto e nelle vene Metello. “Non cresce, non muta, non ha crisi”? Ma crescessi tu, come lui. Voleva fare solo l’uomo medio ‘sto cristiano – né meglio né peggio degli altri – e si ritrova a dover fare il capo e il sobillatore, ci va pure in galera, che altro deve fare di più? Deve uscire dalle pagine e ti deve dare una bastonata in testa? Dice: “Ma sono le circostanze, che ce lo portano”. E certo che sono le circostanze che ce lo portano; ma questo è il realismo socialista: uno diventa quello che è, non è che ci è nato, se no è idealismo, non è materialismo storico. “Sì, però va coll’amante e sta più in camera da letto che alla camera del lavoro”. Ma vaffallippa va’, ma tu che cosa ti credi che è, un romanzo?
Un romanzo mica deve essere l’Imitazione di Cristo o un libro di preghiere. Un romanzo – anche se socialista o realista-socialista – è storia di gente vera che deve servire sì, pure ad edificare, ma se chi lo legge si deve in qualche modo identificare, è necessario che la gente e i personaggi ivi rappresentati siano veri per davvero. Se io costruisco un eroe solamente buono e senza nessuna macchia e nessunissima paura, il lettore dice: “Questo è il mondo della favole, la gente così, nella realtà non c’è. Figùrati se ci posso diventare io”. Il personaggio quindi bisogna che sia credibile, e per essere credibile deve essere umano come me, con tutto il bene di questo mondo, dentro la sua anima, ma pure il male. Mi devi far vedere pure un po’ di male, se vuoi che io creda a tutto il bene che c’è in lui. Luci ed ombre si dice, chiaroscuri. Se no sono chiacchiere e basta. E quindi tanto più credo alla forza di Metello e alle sue positività, quanto più me lo hai fatto vedere pure nell’ambascia di chi, per correre dietro a un paio di mutandine, un altro po’ manda a puttane non solo il matrimonio suo, ma fin lo sciopero e la lotta di tutti gli operai edili di Firenze (non so perché, ma mi viene in mente pure Berlusconi).
Ora però non è una novità che l’intera storia della letteratura italiana sia sempre stata abbastanza parca – per non dire assolutamente priva, fino almeno al Novecento – di romanzi e soprattutto di romanzi popolari; dove per popolare non si intende il semplicemente basso o triviale o di pura evasione, ma l’accezione che di nazionalpopolare dà Gramsci, e cioè la trattazione, con lingue e forme di piena accessibilità anche agli strati più bassi della popolazione, dei temi e valori alti che pure stanno radicati in profondità in seno al popolo e che costituiscono, nella specificità della sua tradizione, le basi e i fondamenti di una comunità nazionale. A differenza per esempio di Francia ed Inghilterra – dove fra Sette ed Ottocento il romanzo popolare fluisce a iosa, basti pensare a Stendhal, Balzac, Hugo, Stevenson, Swift, De Foe, etc. – noi produciamo solo Manzoni con I promessi sposi. Poi basta (dice: “C’è l’Ortis”. Sì, ma è cosa piccola. Non è il romanzo la preoccupazione di Foscolo. Lui fa altro. Fa poesia e critica. E poi Le ultime lettere di Jacopo Ortis – pur bellissimo – è un calco de I dolori del giovane Werther di Goethe. Ed è un romanzo epistolare. Che si scrive, tutte queste lettere il popolo?).
Secondo uno splendido libro di Carlo Dionisotti (Geografia e storia della letteratura italiana, 1967), la ragione andrebbe ricercata nella genesi stessa della intellighenzia e della letteratura italiana, che si formano proprio avulse dal popolo: tu per studiare, scrivere e continuare a studiare e a scrivere, in Italia dovevi solo farti prete, poiché solo la chiesa ti poteva mantenere. E’ una letteratura di “chierici” la nostra – dice Dionisotti – che in una Italia però divisa in tanti Stati e tanti dialetti si mettono a tavolino e con le Prose della volgar lingua del cardinale Bembo (1525), costruiscono in laboratorio una lingua italiana come fosse l’esperanto. E’ chiaro che è una lingua che nessuno parla. La scrivono solo loro – la res publica litterarum – ed è chiaro che se la scrivono, leggono e parlano soltanto loro tra “chierici”, senza alcunissimo scambio né orale né scritto con il popolo, scriveranno e parleranno solo di temi e di cose che riguardano loro: i “chierici”, non il popolo. Ti possono quindi mai fare il romanzo popolare? (Con le Prose della volgar lingua di Bembo – che è la prima grammatica italiana – tutta l’opera di Dante viene messa all’indice perché scritta male, scritta in una lingua che rispecchia troppo quella parlata dal popolo fiorentino: bisogna scrivere come Petrarca, più difficile e rarefatto possibile. Se no ti capiscono. E Dante viene messo da parte e misconosciuto per due secoli. Verrà riscoperto solo nel Settecento. Da Baretti.)
Vasco Pratolini invece – come si dovrebbe essere capito – non era un chierico, era un autodidatta, figlio di una sarta e di un commesso in un negozio di vernici, che poi si metterà a fare il cameriere. Non è un rampollo delle classi alte, diciamo, e quindi non è che possa iscriversi regolarmente a scuola e frequentare fino al liceo e all’università. A dodici anni deve andare a lavorare. Prima come garzone di barbiere, poi fattorino da un avvocato e, via via, apprendista tipografo, facchino-lift d’albergo, venditore di bibite con chiosco, manovale generico in una ditta di saponi, rappresentante di commercio per un cartonificio e infine impiegato in un istituto di tutela commerciale. Nel frattempo ovviamente non è che dormisse da piedi: legge, legge sempre, qualunque cosa gli capiti sotto, da Pinocchio a Dostoevskij, e frequenta pure qualche corso serale. Lavora, legge febbrilmente e comincia a scrivere racconti. A diciott’anni dice basta col lavoro – adesso voglio scrivere e studiare – e si mette ogni giorno a frequentare i corsi all’università. Ma come uditore, non studente iscritto regolarmente: segue le lezioni e basta, come un intruso. Non sostiene gli esami e non ottiene, alla fine, nessuna laurea che “certifichi” i suoi studi (secondo la psicanalisi, quei “pezzi di carta” non servirebbero tanto a certificare agli altri, o alla società in genere, gli studi o le cose che abbiamo fatto, ma servono – in realtà – a certificarlo a noi stessi. Siamo noi che ne abbiamo bisogno per sentirci sicuri). Pubblica le prime cose già nel 1931, diverrà uno dei più importanti intellettuali italiani, dirigerà e fonderà riviste, dal 1942 verrà pure chiamato per “chiara fama” – a meno di trent’anni, nella grande infornata di “chiare fame” benedetta dal ministro fascista Bottai – ad insegnare storia dell’arte nelle scuole e nei conservatori. Ma dentro, deve aver continuato a sentirsi per sempre un autodidatta, una specie di intruso – o quanto meno “non autorizzato” – nell’aula magna della res publica litterarum.
Dicevamo difatti che nel 1955 – quando uscì Metello – la critica più blasonata, quella “militante”, lo prese a legnate, come peraltro prese a legnate qualche anno dopo, nel 1960, anche La ragazza di Bube di Carlo Cassola, per non dire di Bassani. “Liale” li chiamavano, dal nome della più famosa scrittrice di romanzi rosa del Novecento. Ma che ci vuoi fare? Chi nasce tondo non può morire quadrato, dice un proverbio. Quelli sono “chierici”: come vuoi che li capiscano, dei libri così?
Il dramma vero però è che il primo a credere ai critici sembrerebbe essere stato Vasco Pratolini stesso (per fortuna nostra non gli credette il pubblico: Metello vinse subito il Viareggio nel 1955 e da allora non ha più smesso d’essere letto e pubblicato. La riduzione cinematografica del 1970 poi, di Mauro Bolognini – con Massimo Ranieri e Ottavia Piccolo – fu un altro grande successo). Sembra essere lui il primo a non avere l’esatta percezione di sé, e della grande cosa che pure aveva fatto con Metello.
Pratolini afferma di non sentirsi un bravo narratore e che non è Metello il romanzo che davvero voleva fare. Il romanzo vero, evidentemente, anche per lui è un’altra cosa: è quello che prescrivono i critici, il non-romanzo, l’introspezione psicologica, tutto quello che gli avevano raccontato Vittorini, Muscetta, Calvino e gli altri, e poi pure il Gruppo 63 a buon bisogno, e tutti gli intellettuali “chierici” e laureati (roba però che uno a un certo punto dovrebbe pure dire: “Vabbe’, ma allora perché non mi fai vedere tu, che cosa sei capace di fare?”. Be’: due palle così, ogni volta che ci provano o che ci hanno provato. Ma mica smettono. Anzi, insistono pure, a voler insegnare a te come si fa: “Vie’ qua, che te lo dico io”. Li possin’ammazzà).
Pratolini invece s’è fidato ad occhi chiusi. Gli ha creduto come alla zingara. “Se non lo sanno loro?” deve avere pensato. E lui che era il più potente di tutti quelli – l’unico capace di fare il romanzo popolare con Metello, che è uno dei pochissimi veri romanzi di tutta la letteratura italiana, poiché il romanzo è res gestae da che mondo è mondo, e non res cogitatae come credono i fessi: attiene all’estetica, non alla logica – s’è sempre sentito soggetto a loro, subiectus ed inferiore perché non autorizzato, in quanto autodidatta “non laureato”.
Ma tutte queste – ovviamente – non sono che estemporanee sensazioni dell’umile sottoscritto, sensazioni solo estetiche non suffragate ope codicum. Per farlo, ci vorrebbe il tempo, l’uzzo, il buzzo e i mezzi d’un chierico laureato, ma – secondo me – non dev’essere nemmeno un caso che gli ultimi suoi libri escano negli anni Sessanta, quando irrompe e s’afferma con fracasso il nuovo ordine critico-teologale del Gruppo 63. “E mica sarò scemo”, deve avere detto il povero Pratolini. E non ha più scritto né parlato per vent’anni.
(a.p. - marzo 2011)