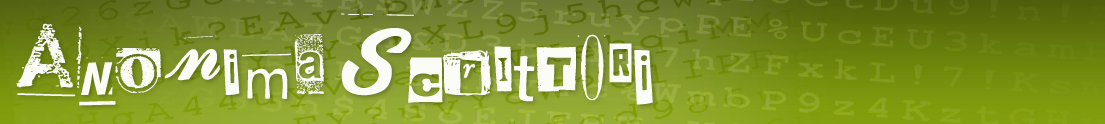L'OMICIDIO DI ROSA E LE VENDETTE. QUANDO FINIRA' L'ODIO?
Doverosa premessa. L’articolo nasce da una discussione, che si svolge prima su un blog e poi su facebook, intorno alla morte di Luigi Di Rosa, a Sezze. Giorgio De Marchis, capogruppo del Pd al comune di Latina, aveva postato un post in memoria di Di Rosa il giorno del 36° anniversario dal suo omicidio. Il sottotitolo era “…per il quale nessuno ha mai pagato…”. Il primo a commentare è stato un utente, firmatosi Luca Baldini, che scrive: “Uno dei partecipanti alla spedizione, Miro Renzaglia, lo abbiamo avuto come candidato nelle liste di Fli le scorse elezioni”. Visto che è stato chiamato in causa, è intervenuto nella discussione Miro Renzaglia: “per il dannato omicidio di Luigi Di Rosa, Pietro Allatta ha pagato con una decina di anni di galera… Angelo Pistolesi con la vita… io con quattro colpi di rivoltella in corpo (ed altri evitati per un pelo)… questo per rispondere al “nessuno ha pagato veramente” di De Marchis… cosa volevate? Una ecatombe?”. E poi la discussione si è spostata sul mio profilo di Facebook, in calce ad un link in cui veniva riportato l’articolo di un’altro De Marchis, Crisitan, sul PD. “Il Pd” ha scritto De Marchis commentando l’articolo del suo omonimo “difende i valori democratici ed antifascisti. […] Vorrei ricordare che non esiste risarcimento per la morte, a meno che qualcuno non dia il giusto valore alla vita. Questi sono i valori che difende Bersani e questo basta e avanza per distinguere la sinistra dalla destra”. Perché ho deciso di intervenire io, che c’entro solo indirettamente? Anche io credo che una vita non sia risarcibile, men che meno con un’altra vita. E’ ancora meno risarcibile con due. C’è chi dice che intervenendo, posso solo farmi terra bruciata intorno nel mio ambiente di provenienza, cioè a sinistra. Beh, se questa è terra che vuol bruciare, che bruci pure. Non sarò certo io a impedire un processo naturale. Vorrei solo riportare, in una discussione che è partita per la tangente e che è offuscata da visioni ideologiche di comodo, da polemiche politiche e da ripicche personali e indirette, la questione un po’ al punto. Chi ha strapagato, chi ha pagato quel che doveva pagare, chi ha pagato poco e chi niente. Perché se davvero ci siamo lasciati alle spalle quell’epoca d’odio viscerale che è conosciuto alla storia come ‘anni di piombo’ – e il piombo non era solo quello del terrorismo conclamato – dovremmo anche saper riconoscere a tutti quel che gli spetta. A Di Rosa, a Pistolesi, a Spirito e a Renzaglia.
Sono di Latina e sono di sinistra. Non posso non sapere chi è Luigi Di Rosa, il diciannovenne che è morto in seguito alle ferite riportate da un colpo di pistola all’addome. Era il 28 Maggio del 1976. Di Rosa è stato definito «martire dell’antifascismo» perché ad ucciderlo fu uno dei due colpi sparati da Pietro Allatta, militante dell’MSI di Aprilia, che di mestiere faceva il metronotte e che quel giorno s’era portato appresso l’arma da fuoco. A dire il vero, insieme alla pistola s’era portato anche i due figli, meno che adolescenti. Una questione privata, quasi certamente, visto che nessuno dei militanti missini era stato informato della pistola, nemmeno Saccucci. Il seguito di Saccucci era arrivato a Sezze dopo esser stato a Maenza e Roccagorga, sui Monti Lepini, la zona rossa della provincia di Latina. Appuntamenti che qualcuno, nella sinistra extraparlamentare dell’epoca e nel PCI, prese come una sfida. Quel giorno, tra i «fasci», la pistola ce l’avevano soltanto in due: Pietro Allatta e Sandro Saccucci. Secondo tutte le testimonianze. Gli altri militanti missini non s’erano portati dietro nemmeno uno stuzzicadenti. E quando circa 200 militanti comunisti, tra extraparlamentari e parlamentari, hanno assediato il comizio missino in piazza IV Novembre a colpi di sampietrini e di sassi, i fasci hanno risposto lanciando bottiglie d’acqua – di vetro, piene – e sampietrini. Solo Saccucci, quando si rese conto che la situazione era compromessa, che lui e i suoi rischiavano di soccombere e chissà in quale modo, ha perso la testa, ha iniziato a vaneggiare dal palco e poi, per spaventare tutti e prendere il tempo giusto per una fuga, ha esploso alcuni colpi in aria. “Se non volete sentire il mio comizio, sentirete questa”. Bum. E poi il fuggi fuggi generale, da una parte e dall’altra. I camerati sono saliti in macchina alla rinfusa, cercando di scomparire tra le vie strette che costituivano l’unico punto d’ingresso e d’uscita da Piazza IV Novembre. I compagni dietro a cercare l’impresa impossibile: raggiungere le macchine, perché quell’affronto – compreso il colpo di pistola – fosse vendicato. Il cordone di vetture, con dentro i militanti missini presenti al comizio di Saccucci, scende dai monti Lepini e cerca riparo a Latina. Mentre si fa la conta di chi c’è e di chi non c’è, arriva lo stesso Allatta che aveva perso il contatto con le altre macchine. Sulla sua macchina era stato gettato un vaso – il parabrezza quasi in frantumi – e la sua vettura, in località Ferro di Cavallo, aveva ricevuto un assalto. C’era chi era riuscito nell’impresa impossibile di raggiungere una delle autovetture che fuggivano. A bordo non c’era solo Allatta, uno dei due uomini armati della spedizione, ma anche i suoi due figli. Lui, sentitosi minacciato, ha fatto fuoco e ha ferito Antonio Spirito, che per fortuna se l’è cavata, e ha colpito a morte proprio Di Rosa, che di quel gruppo faceva parte.
Il monumento eretto a Di Rosa – e dedicato a tutte le vittime (i martiri) dell’antifascismo – ha subito nel corso degli anni ripetuti atti vandalici. Nel 1978, a due anni di distanza dalla morte, è stata addirittura profanata la sua tomba. Gesti di estremo disprezzo non solo nei confronti del simbolo di parte ma anche del ragazzo morto. Un vero e proprio schifo. Perché Di Rosa, almeno a Latina, è il simbolo di una militanza pagata a carissimo prezzo, è la giovanissima vittima, non solo di Allatta e dei fascisti, ma di un intero periodo – gli anni ’70 – in cui un’azione politica significava, per assurdo, esporsi al rischio di prendere un colpo di pistola all’addome. Perché la sua vicenda è emblematica dell’odio tra fasci e compagni. Così Luigi da tempo ha smesso di essere solo un ragazzo di 19 anni che poteva avere mille aspirazioni nella vita, tra cui quella di un mondo migliore e magari anche di un amore e di una famiglia, ed è iniziato ad essere un simbolo. Il «martire» sì, ma di una guerra, a voler essere precisi.
Da allora ad oggi, con una parentesi d’oblio tra la fine degli anni ’80 e i primi anni ’90, non si è fatto che ragionare su quel periodo e su quel clima di violenza. Tra semplificazioni ed esaltazioni, tra oblii che fanno comodo e sottolineature ad orologeria, una qualsiasi delle tante storie di violenza degli anni 70 viene spesso privata degli scampoli, dei piccoli particolari anche significativi, dell’umanità dei coinvolti. E, soprattutto, degli epiloghi. Perché la tragedia che inizia il 28 Maggio 1978 a Sezze non finisce con la morte di Di Rosa. Ha un epilogo che aggiunge disperazione a disperazione, dramma a dramma, morte a morte. Tutti sappiamo della fuga vigliacca di Saccucci che approfittò del dibattito alla Camera sull’autorizzazione a procedere per rifugiarsi prima in Inghilterra, poi in Francia e poi in Argentina. Non tutti invece sanno che la giustizia sommaria dell’antifascismo militante romano condannò a morte, per l’omicidio Di Rosa, due dei militanti presenti al comizio di Saccucci a Sezze, Maenza e Roccagorga: Angelo Pistolesi e Miro Renzaglia. A loro carico non c’era alcuna prova che li collegasse all’omicidio. Le forze dell’ordine, che li fermarono appena rientrati a Roma e li portarono subito in caserma, gli contestarono il reato di rissa per gli scontri di Piazza IV Novembre, quelli delle bottiglie di vetro piene e dei sampietrini. Nient’altro.
Il 28 Dicembre 1977, un anno e mezzo dopo l’omicidio Di Rosa, Angelo Pistolesi venne ucciso sotto casa sua, erano le otto di mattina ed era appena uscito di casa per recarsi a lavoro – all’Enel – dopo aver salutato le due figlie e la moglie. Un uomo avvicinatosi con calma e a volto scoperto, la cui identità non è mai stata svelata, l’ha ammazzato a soli 31 anni con tre colpi a bruciapelo. Sul finire del 3 Marzo 1979 – era mezzanotte meno un quarto –Miro Renzaglia venne aggredito, mentre rientrava a casa, da un commando che gli ha sparato diversi proiettili, di cui quattro sono andati a segno. L’azione verrà rivendicata con un volantino firmato ‘Nucleo proletario antifascista Roberto Scialabba’. Un gruppo che non aveva mai fatto niente prima e che non farà mai più niente dopo. Miro l’hanno ripreso per i capelli, mentre scivolava verso la morte, i medici dopo una delicatissima operazione su cui non potevano fornire, a priori, alcuna garanzia. Per l’omicidio e il tentato omicidio, ancora oggi, non c’è alcun responsabile. Ma nemmeno nessun sospettato e nessun fermato.
Facciamo un bilancio. Dal 28 Maggio 1976 e per quasi tre anni, fino al 3 Marzo 1979, la vicenda di Sezze ha provocato due morti e due feriti, di cui uno gravissimo diciamo quasi morto. Luigi e Angelo, Antonio e Miro. Quattro ragazzi che si sono ritrovati a fare militanza politica in un’epoca in cui chi non si schierava, da una parte o dall’altra, era considerato un minus habens. Quattro ragazzi che non sono mai stati coinvolti in chissà quali azioni pericolose ma che hanno pagato l’essere presenti lo stesso giorno nello stesso identico posto. Vittime dell’irrazionalità, vittime dell’odio senza senso. Perché sono vittime, altro non sono, tutti e quattro. E lo dico da militante che è rimasto di sinistra e che continua a vivere a Latina. Che si rifiuta di prestare il proprio cervello a campagne di propaganda che si basano su un odio fuoritempo e che preferisce tener presente che la vita di una persona – compagno o camerata che sia – è sempre più importante di qualsiasi altra cosa. Ho smesso di essere antifascista perché non ha più senso. Così come non ne ha l’essere anticomunista. Preferisco definirmi antiautoritario, al di là delle bandiere, dei simboli e dei sistemi elettorali. E’ proprio in questa nuova forma di rispetto per le libertà individuali, intese come scelte personali, che si sostanzia il mio essere democratico, progressista e di sinistra. Ed è proprio in virtù di questa scelta di fondo che non riesco a fare differenze tra morti e feriti. Nella mia bilancia due morti hanno lo stesso identico peso. Così come due feriti. Le morti si sommano, non si compensano mai.
E’ sacrosanto che a Sezze ci sia il monumento dedicato a Luigi Di Rosa. Che la sua (anche mia) parte politica lo ricordi. Meritevolissima l’iniziativa del Comune di Sezze, con il sindaco Andrea Campoli, che proprio quest’anno ha istituito il premio Di Rosa per gli studi sul periodo che va dal 1968 a tutti gli anni di piombo. Perché solo così si riesce a dare un senso alla morte di quel ragazzo, ad affrontare l’intero periodo – così come l’intera vicenda Di Rosa – rispettando tutti i morti e tutti i feriti. La storia non ha parte politica, la storia sono fatti e i fatti sono informazioni. E mi piacerebbe anche che qualcuno, nella fattispecie chi organizzò quel gruppo d’assalto al comizio di Saccucci – perché duecento persone in piazza non ci vanno spontaneamente –, approfitti di questo nuovo clima per riflettere su quel che ha determinato con le proprie decisioni. Perché se c’era responsabilità morale per Saccucci, c’era sicuramente anche per lui. Se è deprecabile il comportamento di chi è scappato davanti alla giustizia, è deprecabile anche chi si nasconde ancora. Perché è sicuramente responsabile e assassino chi spara ad un ragazzo, ma è co-responsabile anche chi lo mette davanti a quella pistola.
(Articolo pubblicato da Il Fondo e da Gli Altri Online)