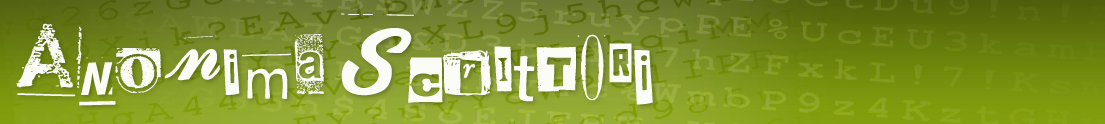Per K. (so che è lungo e farà due palle così... ma così l'ho fatto :D)
DA CHOMSKY A BERSANI.
Il giorno dopo le elezioni, tornando da Roma, ho comprato Il Manifesto. Erano anni che non lo facevo. Forse l'ultima volta che sono andato in edicola a chiedere Il Manifesto è stato al primo anno d'università. All'epoca volevo sembrare più comunista di quanto fossi in realtà e uno dei modi migliori, per mostrare a tutti che ero un compagno a 24 carati, pensavo fosse quello: comprare il quotidiano comunista. La motivazione che m'ha spinto questa volta a comprare il giornale fondato da Parlato e Rossanda, e per questa volta intendo il day after la debacle elettorale della sinistra 'ufficiale', era completamente diversa rispetto a diversi anni fa. “Chissà che si sono inventati”, ho pensato. Adesso che la sinistra è scomparsa, o quasi, chissà quelli del Manifesto che analisi complicate tireranno fuori.
Sono arrivato alla stazione con un certo anticipo, gli scompartimenti del treno erano ancora di là dal riempirsi e mi sono accomodato sul sedile. Ho aggrottato le ciglia alle dichiarazioni di Ingroia che tenta di spiegare la debacle di Rivoluzione Civile scaricando la colpa su Bersani – che di colpe ne ha una valanga, tranne quella che gli imputa l'ex magistrato – e ho anche sorriso nel vedere che, sotto sotto, i giornalisti de Il Manifesto si compiacevano del successo di Berlusconi. Dopo un anno e mezzo, e tanta paura che fosse finito per davvero, avevano ritrovato il nemico di sempre. Monti d'altronde era troppo scialbo e ordinario per costituire un nemico vero, uno con cui prendersela sul serio. I giornalisti del quotidiano comunista me li sono immaginati, davanti agli schermi del computer, con lo stesso sguardo compiaciuto di Zenigada quando rivede Lupin all'azione. L'uno è funzionale all'altro. Personaggi di una tragicommedia che funziona e che, proprio perché funziona, viene replicata ad ogni elezione, da molti anni a questa parte.
Poi, finita la parte politica, mi sono tuffato nella pagina culturale. E ho trovato una interessantissima intervista di Marco Dotti ad Andrea Moro, allievo di Noam Chomsky e autore del saggio “Breve storia del verbo essere”. Sono rimasto folgorato. Così ho deciso di socializzare, oltre all'acquisto insolito dopo anni d'astinenza, anche la folgorazione stessa.
Si parlava di istinto, a cui Chomsky spesso si richiama. E viene citato un passo del linguista statunitense: “L'uomo che ha appreso una lingua è come il ragno, non impara a tessere la sua tela perché un esemplare più adulto e esperto glielo ha insegnato, ma perché ha un cervello da ragno”. Il linguaggio, secondo Chomsky e quindi secondo Andrea Moro, è un'espressione della natura e non della cultura. “Quest'idea dell'istinto è una citazione da Darwin” spiega Andrea Moro “il quale, da parte sua, afferma che quando impariamo a camminare, non impariamo a farlo perché culturalmente predisposti alla marcia, ma perché abbiamo l'istinto per alzarci in piedi e andare”. In soldoni: parli perché sei nato per farlo, parleresti – comunicheresti, forse è meglio – anche se nessuno te lo insegnasse mai. Hai un cervello da uomo ergo parli. E' una fornitura di serie, usciamo così direttamente dalla casa madre. Allora il giornalista, la domanda successiva, chiede a Moro come mai Chomsky sia accusato dai più di utilizzare un linguaggio oscuro per spiegare questo concetto semplice. E Andrea Moro risponde: “Noam Chomsky non è oscuro. Chomsky appare oscuro, perché oscuro appare il nostro cervello. Ciò che di importante Chomsky ci ha insegnato a fare è stato passare attraverso un'apparente complicazione dei dati, per arrivare a una semplificazione superiore”. Più giù nella stessa risposta, Moro riferisce un concetto espresso da Jean-Baptiste Perrin, premio Nobel per la fisica nel 1926. “Il compito dello scienziato è quello di “spiegare ciò che è visibile e complicato con ciò che è semplice e invisibile”.
M'è venuto in mente il centrosinistra e Bersani. Perché, mutatis mutandis, il compito del politico dovrebbe essere quello di rendere semplice e ideale, ciò che è complesso e concreto.
Il tema centrale di queste elezioni è stata la crisi, in tutte le sue sfaccettature: imprenditoria, lavoro, sacrifici, tasse. In un quadro di disperazione che più passano i mesi e più s'allarga, Bersani cercava di conquistare il voto degli italiani in questa maniera: “bisogna mettere fuori dal calcolo del deficit un po' di investimenti sul lavoro. Servono politiche più simili a quelle che fanno negli Stati Uniti” (assemblea del PD a Cantù). Non utilizzava espressioni più semplici come “lavoro per i giovani”, “favorire gli investimenti delle imprese”, “sviluppo, sviluppo, sviluppo”. Il segretario nazionale Pd, candidato alla presidenza del consiglio, si limitava a descrivere un complesso meccanismo di reperimento dei fondi che si discute, in genere, nelle segrete stanze di qualche ministero, tra tecnici e burocrati di Stato. E lo faceva rimanendo comunque sul vago. Insomma, una idea semplice come “investire sulla creazione di nuovi posti di lavoro” veniva resa complicata e, per di più, veniva banalizzata. Il massimo dell'oscurità. Al contrario di Chomsky, una oscurità inutile. L'invisibile e complicato, per rifarci al semplice schema di Perrin.
Bersani – e come lui tutto il centrosinistra, gli esempi potrebbero essere moltissimi, il primo che mi viene in mente è il “cuneo fiscale” di Prodi – si limita a descrivere il processo, perdendosi nell'oscurità del linguaggio tecnico, senza arrivare alla conclusione. Senza descrivere cioè l'obiettivo dei provvedimenti legislativi. Poi qualcuno, nel commentare la puntuale sconfitta, sostiene che gli italiani non capiscono. E cosa dovrebbe capire l'elettore, se nemmeno chi parla sa cosa vuole, proprio perché non si sa esprimere in maniera diretta ed efficace? Il processo, per definizione, è sempre una cosa cervellotica, complicata, piena di specifiche. Sono 20 anni – o forse di più – che nessuno a sinistra spiega il complicato e concreto con il semplice e l'ideale. Tradotto in soldoni: riuscire a far capire il fine delle proprie azioni – future – di governo con una frase, una parola. Questo il compito del politico che si definisce – come fa Bersani e tutto il PD – dell'Italia “giusta” e “perbene”.
Anche qui, a livello semantico, siamo ancora in alto mare. Perché l'Italia “giusta” e “perbene”, fa intuire che, dall'altra parte, c'è un'Italia “ingiusta” e “permale” che non deve essere votata proprio in quanto tale. E' proprio a partire dal refrain della campagna elettorale che il PD si pregiudica la maggior parte dei consensi. Perché elimina subito alla radice ogni eventuale confronto programmatico, oserei dire che rende superflua ogni spiegazione. “Sono l'Italia giusta e perbene. A cosa serve spiegarti cosa voglio fare?”. Il PCI è scomparso dalla faccia della politica, il muro di Berlino è caduto, ma la superiorità 'presunta' dei comunisti non è terminata. Ammesso che possa mai esistere – e non esiste – una divisione così manichea come quella che viene suggerita dal PD, bisognerebbe anche prendersi la briga di dimostrare – e rientriamo nel procedimento scientifico – che si è l'Italia giusta e perbene alle proposte che vengono fatte. Non si tratta di evocare sogni e sentimenti, che mica da Bersani ci aspettiamo un film, una poesia o un romanzo. Nemmeno da Veltroni ce lo aspettavamo, ma lui ha insistito così tanto da raggiungere la sconfitta più bruciante – nella sostanza, magari non nella forma – della storia.
Più semplicemente è una questione del 'far capire' cosa si vuole, dell'essere chiari, dell'arrivare alla gente.
Ma qui arriviamo alla difficoltà di fondo. D'altronde l'unico modo per capire la ragione ultima, era rifare il processo al contrario: constatare la mancanza della conclusione, ricostruire il caso del processo, arrivando al nocciolo della questione. Il PD, nato com'è da due tradizioni differenti e diciamo pure opposte, si ritrova a dover mediare sempre tra spinte completamente opposte. Su una tematica come quella dei diritti civili, la questione è lampante. Non c'era, purtroppo per tutti, solo la Binetti ad opporsi al riconoscimento delle coppie omosessuali. La classe dirigente rimasta nel centrosinistra, è piena di personaggi che ragionano alla stessa maniera. Anche sull'etica, molti componenti del PD stanno da una parte e tanti altri da tutt'altra. E questo complica parecchio una comunicazione chiara. Ma col tempo la divisione s'è allargata a tanti altri temi: il lavoro, lo stato sociale, l'istruzione. Forse non è rimasto più un solo argomento in cui tutti, nel PD, sono concordi. E le correnti si sono moltiplicate che nemmeno Gesù col pane e i pesci. Sono nati i liberisti, i MoDem, i giovani turchi, i dalemiani, i bersaniani, i fioroniani, i mariniani, i civatiani, i serracchiani e chissà quanti altri gruppi e gruppuscoli di cui s'ignora l'esistenza. Ognuno con le sue specifiche, con le sue richieste particolari, con i suoi 'però' da sottolineare. Che poi è il solo modo per dimostrare l'esistenza in vita di ogni singola corrente. Ad ogni proposta si aggiungono le virgole, si limano gli aggettivi, si chiede l'aggiunta di qualche altro sostantivo, si chiede la sintesi e poi la prolissità. Si allunga e si stira il testo in maniera così violenta che la forma si complica e il senso si perde.
Così il destino del PD diventa paradossale, prodotto – per ora degenerato – di diverse tradizioni: comunista, socialista e democristiana. Tre tradizioni che alla base del loro agire politico avevano un fine chiaro: una società di eguali, una società più giusta, una società migliore. L'agire quotidiano era facilmente interpretabile – anche se magari l'ideale spesso era troppo lontano, e l'agire quotidiano si piegava alla 'dialettica degli eventi' – e gli elettori avevano ben chiaro da che parte stare. Adesso col PD le cose si sono fatte complicate.
Le idee più chiare che sono arrivate all'elettorato - perché forse sono le uniche su cui nel centrosinistra vanno d’accordo - sono quelle della 'governabilità' e della 'responsabilità'. Due concetti conservatori – venitemi a dire il contrario – che hanno a che vedere più con le dinamiche parlamentari e le leggi elettorali – materia complessa e articolata – che con la vita quotidiana della gente. Si capisce insomma la voglia di governare, ma non si capisce che cosa si voglia fare una volta al governo. Così come la responsabilità: che l'abbiamo capito tutti che è responsabilità nei confronti della BCE, dell'Europa, dei mercati, degli alleati, dei nemici. Responsabilità che non è mai, o è di rado, nei confronti del cittadino. Il primo a cui un politico dovrebbe pensare quando dice “responsabilità”.
Proprio per questo, forse, il PD ha preso meno voti alla camera e al senato. Mentre i più anziani, ancora si perdono nella nostalgia di Berlinguer e dell'antifascismo e di tutti gli altri feticci davanti ai quali è costretto a riunirsi ancora oggi l'uomo/la donna di sinistra. Per i giovani il discorso è diverso: hanno più a cuore il loro futuro che il loro passato, magari la storia la conoscono e proprio per questo vorrebbero evitare di dare il loro voto ad una forza di conservazione, qual è il PD oggi. Perché il PD, con la governabilità e la responsabilità, più che far progredire la società, vuol conservare lo status quo magari aggiustando eventuali storture. Da forza anti-sistema a forza pro-sistema. Con quell'idea fissa del governare, che sta diventando – come abbiamo visto prima – un semplice 'governare per governare'.
E il sospetto ultimo è che dietro questa fissa del 'governare per governare', dietro questa difficoltà endemica del 'farsi capire', si nasconda proprio la mancanza di idee, di proposte, di futuro. Il PD è in stato confusionale, tirato com’è da una parte o dall’altra delle diverse correnti. Stato confusionale che emerge chiaramente limitandosi a fare un’analisi del linguaggio utilizzato per propagandare le non-idee.