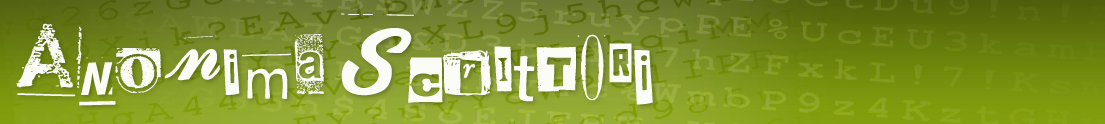Saro´ la solita catastrofista ma io credo che tutta la nostra classe politica sia ormai cosi´ corrotta e scorretta che sia solo una perdita di tempo da vecchi idealisti continuare a scegliere se sia meglio la destra o la sinistra, che sono morte da un bel pezzo! Quando fa comodo a loro a volte sono nemici a volte amici, il tutto alle nostre spalle! Quando non rimarra´ piu´ un solo pezzo di questo banda di delinquenti allora forse ricomincero´ a schierarmi, a farmi rappresentare e a votare!
Forum Anonimascrittori » Anonima Scrittori
la morte della patria 2
(75 articoli)-
Pubblicato 14 anni fa #
-
Questo pezzo di Gad oggi su Repubblica è assai acuto. Vorrei sapere cosa ne pensiate. Lavorando a contatto con i giovani, vi dico che le cose stanno cambiando. Per fortuna, sono loro la speranza, in questo paese. I vecchi pensano solo a se stessi, sono tendenzialmente conservatori. Vale anche per noi quarantenni, certi che non si possa nemmeno immaginare un'alternativa a questo stato di cose. Vediamo il nostro mito mobilitante in un Steve Jobs, nvece che in questi giovani. Ideologia, di cui siamo vittime. Non vediamo il futuro, che si annuncia. Pensiamo che il reale sia il necessario. Non immaginiamo altre vie d'uscita. Ma siamo destinati a essere smentiti. la storia va avanti.
A.
________________________________________________________________
I ragazzi e la tirannia anonima della finanzaMentre la politica italiana s’ingarbuglia nella complicata liquidazione del berlusconismo, le prime vittime della Grande Depressione, cioè i giovani, mirano più in alto. Da temerari, lanciano una sfida globale contro la superpotenza finanziaria. Usano lo spagnolo per definirsi indignados. Scrivono in inglese i loro striscioni: Save school, not banks! S’interconnettono nella scelta dei bersagli: agenzie di rating, Borsa, banche d’affari, istituzioni finanziarie sovranazionali. Se la primavera araba ha abbattuto dei tiranni decrepiti, l’autunno occidentale si misura con l’anonimato di un’altra tirannia che traballa: i dogmi di un’economia incapace di distribuire equamente il benessere.
Troppo facile accusarli di velleitarismo, ora che il loro movimento ha circondato perfino il santuario di Wall Street. Neanche il più nostalgico dei marxisti avrebbe osato pronosticare un simile evento storico: lo spettro dell’anticapitalismo si aggira per gli Stati Uniti d’America? Calma e gesso, l’individualismo e lo “spirito animale d’intrapresa” restano connaturati all’America. Mai però la contestazione aveva insidiato prima d’ora i forzieri del capitale, là dove buona parte della ricchezza planetaria viene convogliata e ripartita secondo criteri incomprensibili a noi comuni mortali. Fino a erigere la piramide assurda dell’ingiustizia sociale che neppure i suoi beneficiati osano più giustificare.
Nella Grande Depressione in corso ormai da quattro anni, ha proliferato dapprima diffuso un senso comune anti-élitario, di destra o di sinistra. E ora ne scaturisce un’inedita contestazione eretica dei vincoli dell’economia di mercato. Quando è apparso evidente come all’arricchimento smisurato di pochi corrispondesse l’impoverimento di nazioni intere, gli indignados hanno lanciato la rivolta contro gli intoccabili.
Questi giovani pretendono (si illudono?) di dare un volto ai giocatori che speculano sull’azzardo finanziario. Denunciano le conseguenze di un debito da costoro continuamente riacceso e dunque (solo per loro vantaggiosamente) infinito. Insieme ai tecnocrati, contestano i professori di economia arcisicuri che la sofferenza sociale vada sopportata, perchè dalla crisi si uscirà prima o poi ripristinando la baldoria di prima.
La simultaneità dei movimenti di protesta giovanile esplosi a ogni latitudine, rompe i vecchi schemi terzomondisti. Oggi è nel cuore del sistema capitalistico occidentale che si genera l’antagonismo sociale, impersonato da soggetti nuovi come i lavoratori della conoscenza. D’un colpo è invecchiata pure la terminologia suggestiva ma generica di Toni Negri sull’”Impero” circondato da “moltitudini” espropriate: un movimento statunitense che si autodefinisce “Occupy Wall Street” esprime ben altro che la protesta delle periferie del pianeta. Atene, Tel Aviv, Madrid, Santiago non sono più così distanti da New York. Semmai è l’Occidente stesso che comincia a patire le conseguenze della sua eclissi. Smette di credere alla favoletta della ripresa dietro l’angolo, perseguibile con apposite manovre governative dettate dall’alto. Dubita dell’efficacia di piani di rientro del debito sempre più onerosi. Si domanda se una civiltà che prevede un limite ai minimi salariali, per sostenibilità non debba contemplare pure un limite ai compensi elevati.
Trovano così cittadinanza, nel senso letterale del termine, le domande scandalose che purtroppo l’accademia e l’establishment commettono l’errore di liquidare con sufficienza.
La politica, compresa la politica di sinistra, evita di rappresentarle, considerandole naif, perché a sua volta affida le proprie chance di successo ai rapporti confidenziali che intrattiene con l’accademia e l’establishment. Nessuno che aspiri a governare l’Italia, per esempio, azzarderebbe una contrapposizione esplicita alla lettera-diktat spedita dalla Bce l’agosto scorso. Gli indignados di casa nostra, viceversa, pretendono di consegnare nei prossimi giorni alla Banca d’Italia una lettera dai contenuti diametralmente opposti.
L’appello messo in rete per la giornata europea di mobilitazione, convocata il prossimo sabato 15 ottobre, si rivolge alla Commissione europea, alla Bce e al Fondo monetario internazionale, assimilati alle multinazionali e ai poteri forti: “Ci presentano come dogmi intoccabili il pagamento del debito, il pareggio del bilancio pubblico, gli interessi dei mercati finanziari, le privatizzazioni, i tagli alla spesa, la precarizzazione del lavoro e della vita”. La replica degli indignados è secca: “Non è vero che siano scelte obbligate”. Alla politica chiedono di esercitare un contropotere rispetto alla superpotenza finanziaria globale, perfino rivendicando il “diritto all’insolvenza”.
L’equazione grossolana secondo cui “il debito non l’abbiamo contratto noi, quindi non lo paghiamo”, comincia a essere declinata in forme più articolate. Come l’ipotesi di un “default concordato e selettivo” a protezione dei ceti deboli. Anche per rintuzzare la voracità di cui sono vittime i paesi più indebitati, come la Grecia, a rischio di spoliazione. E’ una follia questa richiesta di sottrarsi alle regole dei mercati? Può darsi, ma nel caso bisognerà spiegarlo con umiltà a molta gente che nei decenni trascorsi –quando pure furono dei tecnici eccellenti a guidare le politiche di risanamento- ne subirono ingenti decurtazioni di reddito. Neanche l’idea di accollare agli Stati un oneroso piano di rifinanziamento delle banche risulterà accettabile, finché latitano provvedimenti di maggiore giustizia sociale. “Salvate le scuole, non le banche”, appunto.
Succede quindi che su ambedue le coste dell’Atlantico si riconosca un nemico comune. Magari ridotto in caricatura semplicistica da chi imbratta le sedi delle banche e occupa gli uffici delle agenzie di rating. Ma si tratta di una reazione comprensibile di fronte a un’economia trasformatasi in ideologia. Sono due docenti dell’università Bocconi, Massimo Amato e Luca Fantacci, a denunciare il feticcio di un sistema finanziario solipsistico in cui pareva possibile che i conti non si chiudessero e i debiti non si pagassero mai (“Fine della finanza”, Donzelli editore). Fino all’”eternizzazione dell’espediente”: da ultimo, creare debito impagabile prestando soldi a chi non può permettersi di rimborsarli, tanto…chi vivrà, vedrà.
Ecco, non si può pretendere che gli indignados, italiani, greci, islandesi, spagnoli o americani che siano –comunque figli rimasti esclusi dai nostri privilegi- credano ancora che l’innovazione sia di per sé portatrice di miglioramento. La creatività dei finanzieri, se mai fu ammirevole, oggi risulta detestabile. E per favore non chiamatela invidia sociale.
G. Lerner - La Repubblica 8.10.11Pubblicato 14 anni fa # -
io quando sento parlare o leggo Lerner, mi tocco i coglioni.
Pubblicato 14 anni fa # -


 Pubblicato 14 anni fa #
Pubblicato 14 anni fa # -
Scende in campo il papa: la patria è salva. Non andrà più all'inferno.
Pubblicato 14 anni fa # -
l'omino è disperato, quell'altro dorme. Poraccio. Ma lasciatelo dormire, non je fate fa le nottate.
 Pubblicato 14 anni fa #
Pubblicato 14 anni fa # -
Se in tutto il mondo la manifestazione degli indignati di oggi si è svolta senza problemi mentre a Roma si è trasformata in guerriglia urbana ci sarà pure un motivo. Troppo facile dare sempre la colpa ai provocatori.
La responsabilità politica degli scontri di oggi è tutta del governo che negli ultimi 10-15 anni ci ha portati alla disperazione per la sua incapacità di creare lavoro stabile e di dare risposte alle istanza di maggiore giustizia sociale.
Pubblicato 14 anni fa # -
No, anche il fatto che ci sono infiltrati... non je pareva vero al governo in crisi di avere una manifestazione così per infiltrarla, fare violenza e traformarla in un consenso a loro. Ps un militante pacifico di SEL è stato ferito gravemente....
Pubblicato 14 anni fa # -
Già, ma chi li finanzia sti infiltrati? Un giorno qualcuno dovrà spiegarcelo.
Pubblicato 14 anni fa # -
Già, ma chi li finanzia sti infiltrati? Un giorno qualcuno dovrà spiegarcelo.
entra in un qualsiasi centro sociale e prova a chiederglielo direttamente.
Pubblicato 14 anni fa # -
o in qualche sede di partito?
Pubblicato 14 anni fa # -
che sappia io da trento sono partiti quelli del centro sociale "orso bruno" e da vicenza i pacifisti di No Dal Molin.
poi fai te...
Pubblicato 14 anni fa # -
Dal sito della Giulio Einaudi Editore
Lo scorso maggio, durante il Salone del Libro, abbiamo proposto una nuova edizione de L’Italiano di Giulio Bollati. Nell’anno delle celebrazioni per il centocinquantesimo anniversario dell’Unità del nostro Paese, ci sembrava necessario, se non doveroso, rendere di nuovo disponibile un testo che affronta la questione cruciale del nostro carattere nazionale. Un carattere che è prima di tutto un progetto, e che trova proprio nel Risorgimento un suo momento genealogico.
Osservando le immagini di sé che gli italiani hanno prodotto nelle discipline più varie, attingendo alla pittura e alla fotografia, all’estetica e alla linguistica, Bollati ha indagato il processo di costruzione della nostra identità culturale, arrivando a toccare – ed è forse ciò che rende questo libro così attuale – il problema del confronto tra politica e cultura.
Per presentare L’Italiano ai lettori di oggi, abbiamo scelto di far parlare alcuni tra i più importanti intellettuali italiani. Al convegno, intitolato Un’idea d’italiano/Un’idea d’Italia e svoltosi quest’anno durante il Salone Internazionale del Libro di Torino, hanno partecipato Alberto Asor Rosa, Walter Barberis, Gian Luigi Beccaria, David Bidussa, Paul Ginsborg, Sergio Luzzatto, Michela Murgia, Marco Revelli, Salvatore Settis e Benedetta Tobagi. Pubblicheremo, a partire da oggi, alcuni dei brevi saggi su cui si è sviluppato il convegno. A cominciare, in ordine alfabetico, dall’intervento di Alberto Asor Rosa.***
Centinaia di scaffali non basterebbero a contenere le innumerevoli «deprecazioni» italiane per un’identità che avrebbe dovuto esserci e invece non c’era, oppure che c’era stata ma non c’era più. Un solo esempio fra i tanti: quando nel 1540 il crollo catastrofico delle «libertà italiane» è già avvenuto, – e in modo per secoli irreparabile –, in quella che nonostante tutto è la prima, e infatti si chiama Storia d’Italia, Francesco Guicciardini, lui che avrebbe dovuto spiegarcelo, esordisce con un brano di rara forza ed efficacia per chiedersi con stupefazione e con angoscia come tutto ciò fosse potuto accadere.
Stupefazione senza spiegazione: da allora questo singolare nesso tante volte nella nostra storia è stato ripetuto da diventare la sigla più tipica del nostro modo d’essere «italiano», o, come io preferisco dire, «italico».
Insomma: lingua e letteratura; arti, musica, forme artistiche ed espressive; e canti e strepiti di poeti, ammonimenti di storici e di presunti politici; recriminazioni d’insigni uomini di cultura. Questo, non c’è dubbio, c’è, ed è, per quanto la definizione sia di frequente approssimativa, italiano. Ma questa spesso formidabile macchina di cultura, di pensiero e d’immaginazione esce dalle inesplorate profondità della stirpe, ma poi cala dall’alto, senza mai fondersi compiutamente con il basso, che è, e resta, nonostante tutti gli sforzi, un’altra cosa. Macchina di cultura, di pensiero e d’immaginazione indubitabilmente formidabile, ma in Italia sempre sempre minoritaria, talvolta ai limiti della setta o della conventicola segreta.Gli italiani a loro volta si dividono in due specie nettamente distinte, anzi, più esattamente, contrapposte: quelli che troverebbero opportuno fondere le due cose, l’alto e il basso, l’identità culturale e l’identità nazionale, la cultura e la politica, e a questo fine lottano, si battono ed eventualmente sono disposti a morire; e quelli ai quali nulla importa di meno che raggiungere tali obiettivi. Chiamo i primi italiani, i secondi non italiani.
Devo precisare: la distinzione non è strettamente politica né ideologica: il fascismo, dopo il fallimento liberale (verificatosi in gran parte proprio su questo terreno), ha tentato a modo suo, – naturalmente per una strada sbagliata, – di fare anch’esso ciò di cui stiamo parlando. La distinzione è più profonda: ha basi storiche lontanissime, natura antropologica, alla fine esiti anche esistenziali. I non italiani sono la zavorra mefitica che ci consegna il nostro passato plurisecolare: quelli del «Franza o Spagna purché se magna», del particolarismo municipale o familistico (quello che Marco Revelli chiama il «familismo amorale» in uno dei libri più belli che siano stati scritti recentemente sulla «condizione italiana», Poveri, noi): insomma, quelli che c’erano prima di qualsiasi Stato di diritto e non hanno partecipato per niente alla sua fondazione. Quando una soluzione politica raggruma la spinta dal basso che viene dai non italiani, è aperta la strada a un governo popolare sostanzialmente arbitrario e potenzialmente totalitario.Nella plurisecolare storia dell’incompiutezza italiana ci sono stati due momenti (se accantoniamo il fascismo, che ovviamente richiederebbe un discorso a parte), in cui la saldatura, sia pure entro certi limiti, invece si è verificata: Il Risorgimento e la Resistenza. Ma affinché questo accadesse, c’è voluta la contemporanea presenza di due fattori rari e indispensabili: un forte ceto politico e una forte classe intellettuale, e la loro conseguente alleanza verso obiettivi comuni, talvolta nella sostanza diversi, ma in tale prospettiva agiti come armonici.
Che tali fusioni siano da considerare eccezionali, e non normali, lo testimonia la presenza in ambedue i casi di un terzo fattore, e cioè l’uso delle armi, e cioè l’adozione sistematica e programmatica della forza o, se si preferisce, della violenza.
Naturalmente, questo non è un consiglio, né tanto meno un’esortazione, ma solo una sofferta constatazione, che però consente di aggiungere l’ultimo tassello al nostro discorso sull’incompiutezza italiana: dalla sua incompiutezza l’Italia non è mai uscita per le vie normali. Gli italiani non sono mai stati capaci di una normalità nobile, elevata, produttiva. In Italia la normalità produce mediocrità e la mediocrità produce decadenza. E nella decadenza il potere passa o resta più facilmente nelle mani dei non italiani; e i non italiani contagiano più facilmente gli italiani.
Oggi che il governo del paese è nelle mani dei non italiani, e non c’è un forte ceto politico, e non c’è una forte classe intellettuale, bisognerà lavorare sodo e a lungo, e con grande pazienza, perché, diversamente dal passato, questa maggioranza torni a essere, e per le vie normali, una maggioranza di italiani.Alberto Asor Rosa
Continuiamo a pubblicare i brevi saggi presentati al convegno Un’idea d’italiano/Un’idea d’Italia, che si è tenuto lo scorso maggio al Salone del Libro di Torino in occasione dell’uscita della nuova edizione de L’Italiano di Giulio Bollati.
Dopo l’intervento di Alberto Asor Rosa, vi proponiamo quello di Walter Barberis.***
A proposito de L’Italiano di Giulio Bollati
In omaggio a L’Italiano di Bollati, e per una possibile definizione della fisionomia dell’italiano, tre considerazioni.
La prima, desunta da una Scorciatoia di Umberto Saba: «Vi siete mai chiesti perché l’Italia non ha avuta in tutta la sua storia – da Roma a oggi – una sola vera rivoluzione? La risposta – chiave che apre molte porte – è forse la storia d’Italia in poche righe.
Gli italiani non sono parricidi; sono fratricidi. Romolo e Remo, Ferruccio e Maramaldo, Mussolini e i socialisti, […]. Gli italiani sono l’unico popolo (credo) che abbiano, alla base della loro storia (o della loro leggenda) un fratricidio. Ed è solo col parricidio (uccisione del vecchio) che si inizia una rivoluzione.
Gli italiani vogliono darsi al padre, ed avere da lui, in cambio, il permesso di uccidere gli altri fratelli».
Risultato: ancora oggi reclamiamo una memoria condivisa, piagnucoliamo sulla mancata elaborazione dei nostri lutti familiari, diciamo di volere una reductio ad unum e intanto moltiplichiamo i giorni della memoria, ciascuno in rappresentanza delle molte fazioni che continuano allegramente, e tignosamente, a popolare il nostro Paese.Seconda considerazione: questa frammentazione e questi antagonismi interni sono stati un pezzo fondamentale della storia italiana, persino nei momenti universalmente giudicati virtuosi. La civiltà urbana radicata nel comune medievale fu tutta una cornucopia di esiti artistici e commerciali, di opulenze e di ostentazioni: Firenze, Milano, Roma, Genova, Venezia, ma naturalmente Siena, Pisa, Mantova, Ferrara, Urbino e molto molto altro. Ciascuna di queste realtà, tuttavia, giocò la sua partita contro le altre, mosse guerra alle altre, si estenuò per sopravanzare e annichilire le altre. Non c’è manuale di storia italiana che non metta in successione la parola «Rinascimento» con la parola «crisi».
Uno dei più originali e moderni pensatori dell’Ottocento italiano, Carlo Cattaneo, pensò che la soluzione fosse un foedus, un patto, che stringesse come mai prima le varie realtà urbane italiane, fissando qualche vincolo comune e lasciando ampia libertà di governo locale. Sullo sfondo aleggiavano gli Stati Uniti e, con meno fascino, la Confederazione dei cantoni svizzeri. Ci credeva davvero: scrisse a questo proposito La città considerata come principio ideale delle istorie italiane. Ma l’Italia non era adatta al federalismo. Esattamente nello stesso giro d’anni, discutevano accanitamente di unità nazionale persone che avevano idee totalmente diverse fra loro e che si combatterono aspramente per assicurarsi una prevalenza politica. Cavour disprezzava Vittorio Emanuele II; Cattaneo pensava che entrambi rappresentassero il cancro del centralismo statalista e l’arretratezza culturale del Piemonte sabaudo, radicato in tradizioni feudali e non già comunali; Mazzini voleva la repubblica e cospirava esule in ogni angolo d’Europa, inseguito da condanne in contumacia emanate da tutti i governi italiani; Garibaldi era anch’egli repubblicano, ma democratico, azionista e internazionalista, ateo, anticlericale e protosocialista. Tralasciamo, per ovvi motivi i Borboni, il Papa e altri pur famosissimi comprimari. Ciascuno aveva dei retroterra ideali, e locali: Torino, Genova, Milano, Firenze, Roma, Napoli, Palermo. In questo contesto, per scelte meditate e insieme per fortuite coincidenze, nacque il primo Regno di una Italia unita. Ma immediatamente si scatenò una guerra civile, che lasciò sul terreno 15.000 morti; e si radicò in più parti una patologia dei rapporti fra Stato e società che lasciò gli italiani propensi a non avere virtù civiche. Subito l’Italia si dette una immagine che avrebbe troneggiato lungamente nelle più varie rappresentazioni: e cioè le forme di una fanciulla, vestita di una tunica classicheggiante, con il capo cinto da una corona turrita, a dire che la sola possibile veduta unitaria era quella delle varie torri cittadine, elemento comune di una irredimibile diversità e pluralità di luoghi.Terza considerazione. Per fortuna gli italiani sono stati dei migranti. Non solo fuori d’Italia, tantissimi; ma anche dentro l’Italia. Tutto cominciò a Torino, dopo il 1848, con una costituzione, lo Statuto Albertino. Quella carta garantiva libertà di associazione politica, libertà di stampa e libertà di culto. Vennero a Torino circa 50.000 persone: fra loro, il fior fiore delle intelligenze italiane, da ogni parte. Da allora, Torino non cessò di essere luogo di approdi, prima di burocrati, come capitale istituzionale; quindi di operai, come capitale industriale; ma anche di uomini di scienza, come capitale tecnologica; e di uomini di lettere, come capitale culturale.
Nel 1961, Torino festeggiò il centenario dell’unità nazionale e, insieme, il suo milionesimo abitante. Era la città più settentrionale, geograficamente la più periferica, e al tempo stesso la terza città meridionale d’Italia. Piena di immigrati, era – ed è rimasta – la città italiana con la più alta propensione alla integrazione.
Città di arrivi, partenze e passaggi: ne sono stati protagonisti anche molti intellettuali: fra loro Giulio Bollati, per decenni a capo di una attività editoriale, quella della Einaudi, che ha segnato generazioni di italiani. Era un gigante, fra altri giganti. Io credo che dovremmo ricordarci più spesso, oggi, che noi camminiamo sulle loro spalle.Walter Barberis
Pubblicato 14 anni fa #
Feed RSS per questa discussione
Replica
Devi aver fatto il login per poter pubblicare articoli.