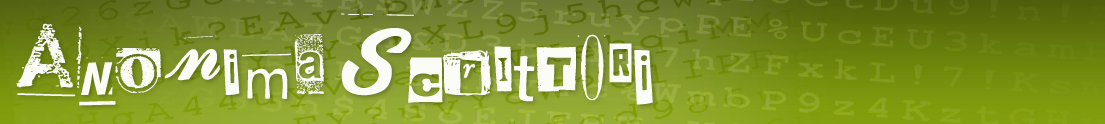[Avevo citato la polemica del Croce sulla poesia di Mallarmé e sull'esegesi che ne fece il Noulet. Il pezzo è lungo, ma val la pena di leggerlo. Per chi volesse saltare. Il pezzo che avevo in mente, quando citavo il commento del Croce, è in grassetto.]
IL 'SEGRETO' DI MALLARME'
di Benedetto Croce
dal libro 'Letture di poeti', Laterza, 1950.
Il Noulet, devoto al Mallarmé e all'arte di lui, dice di aver scoperto il suo 'segreto', che per ben dieci anni ha gelosamente custodito e solo ora mette fuori. Veramente anche io ho sempre tenuto che il Mallarmé avesse un segreto, ma non nel senso che potesse mai rivelarmi tal cosa che avrebbe mutato il giudizio che facevo di quella sua che egli chiamava poesia, la quale avrebbe dovuto parlarmi da sé stessa con voce poetica, ma nell'altro senso che mi spiegasse o mi rendesse comprensibile il processo delle sue aberrazioni, che non era semplice come di tante altre che vediamo presto in qual modo siano nate.
In un fascicolo di una rivistina, l'Artiste del 15 Novembre 1862, alla quale il Mallarmé collaborava, il Noulet ha trovato un articolo col doppio titolo: Héresies artistiques, l'Art pour tous. Il concetto fondamentale di questo articolo è che tutte le arti, sacre come sono al pari delle religioni, si avvolgono nel mistero, salvo la maggiore di tutte, la poesia, che non è protetta contro le «curiosità ipocrite, contro le empietà, e il sorriso o la smorfia dell'ignorante e del nemico». Pensare - egli dice - che Les fleurs du mal di Baudelaire sono stampate nei caratteri e nell'aspetto tipografico di cui gode anche Ponson du Terrail; laddove avrebbero bisogno dei «fermagli d'oro dei vecchi messali» o dei «rotoli di papiro coi logo geroglifici inviolati». La musica, invece, dignitosa e accorta, presenta Macart, Beethoven o Wagner con «processioni macabre di segni severi, casti, ignoti». Donde verso la poesia l’ammirazione imbecille della folla; e l’idea assurda e ridicola di insegnarla nelle scuole, abbassandola al grado di una scienza. La poesia, sciaguratamente, non è riservata, come si dovrebbe, alla gente del mestiere al pari della musica, della pittura, della scultura, ma fa parte dell’educazione dell’uomo completo; e questo è il male, un male di cui hanno colpa gli stessi poeti che «ambiscono alla popolarità, la quale è naturale che sia ricercata dai filosofi, che hanno nelle mani pugni di verità da spargere»; ma il poeta, «adoratore del bello inaccessibile al volgo», dovrebbe contentarsi dei voti del sanhédrin dell’arte.
E questo che il Noulet ha scoperto e chiama «testo prezioso» e vuole ora comunicare anche a noi, è nient’altro che un cumulo delle storture che in riferimento alla poesia riempivano la mente del ventenne Mallarmé. La musica è protetta dalle carte musicali; ma non passa forse, senza quelle carte, nell’anima e nella mente di coloro che la ricantano per udita? E, per contrario, la poesia non ha simili protezioni, ossia impedimenti, nella ignoranza dell’alfabeto o anche, senza questa salutare ignoranza, della lingua in cui è composta? E la pittura e la scultura non è abbandonata ai profani, specie nei giorni in cui le pinacoteche e i musei sono visitati da gruppi familiari di buona gente, che vi fanno intorno i loro ingenui commenti? E che cosa importa che la poesia sia letta in libercoli poveramente stampati se essa è poesia solo quando è ricevuta nell’animo che la ricrea in sé, e l’uscio d’entrata non fa differenza, e anzi certamente è più adatto quello umile che non il grandioso, e le belle edizioni dei poeti non ne accrescono in nulla la poesia né ne accrescono l’ammirazione, la quale, in quelle edizioni, va all’artista tipografo e non all’artista poeta? E perché non si deve o non si può insegnare la poesia? Si insegna come tutte le altre cose, come la filosofia, le scienze, la morale, cioè sempre col presupposto della spontanea disposizione del discepolo a venire incontro e a unificarsi col discente. E il non intendere o il fraintendere la poesia non è forse il medesimo che accade non solo in tutte le arti, ma nella filosofia e nelle scienze e nella educazione morale: pure, un raggio di queste cose penetra nella società umana, un verso, un’immagine, una nota, un pensiero, un dubbio, un esempio, o, per lo meno, si avverte in qualche modo l’esistenza di una sfera superiore al comune conversare e si prova la riverenza verso di essa e sorge l’aspirazione di avvicinarlesi e di farne esperienza. Né è da credere che la poesia la intendano appieno i componenti dei sinedri, cioè i competenti, se appieno non l’intende di solito neppure l’autore, dal quale l’opera, compiuta che sia, si distacca come il frutto dalla pianta, e l’intendimento è un processo di acquisizione che va all’infinito. E mi arresto qui, giacché, innanzi a spropositi che si prendono con le molle, cioè col buon senso, ho già ragionato troppo sul serio.
Ma se il documento che oggi ci è fatto conoscere è curioso, mostrandoci quanto, a vent’anni, poco sviluppato e molto confuso fosse l’intelletto del Mallarmé, concorre altresì a spiegarci come mai egli, da quelle deplorazioni della cattiva avventura che la divulgazione della poesia procura alla poesia, pervenisse al proposito di fare, sotto nome di poesia, tal cosa che differisse da tutto ciò che fin allora si era chiamato con questo nome, e cioè incomunicabile ad altro uomo, che avrebbe potuto, tutt’al più, valersi delle sue suggestioni per farne per proprio conto un’altra, diversa, e concorre altresì a spiegare come egli ponesse il suo ideale nel comporre tale unico e mirabile libro o poema o singolarmente condensata parola da risolvere in un sol atto tutti i problemi del mondo, facendo morire il mondo, e che queste cose lasciasse intravedere ai suoi uditori del martedì, per molti e molti anni; e sempre più si facesse ermetico e sempre più si vuotasse di ogni partecipazione alla vita umana, che ha pur dato materia e stimolo alle opere degli altri poeti che si chiamano grandi; e perdesse via via anche quelle fulgurazioni che ebbe nelle sue poesie della prima o delle prime epoche, e si inaridisse a segno che la raccolta delle sue opere (vedere l’edizione della Pléiade), paragonata a quelle, non dico di un gigante come il Goethe, ma di un Baudelaire o di un De Vigny, dà l’impressione di miseria, perché ai pochi e deboli conati di poesia si accompagnano e li soverchiano grammatichette e compendiucci scolastici o cose frivole come gl’indirizzi di casa dei suoi amici messi in verso e in rima. Le parole che vengono sul labbro a questo spettacolo sono state pronunziate da coloro stessi che gli stettero attorno: due parole che accennano a un che di patologico, «impotenza» e «fissazione», e con ciò si potrebbe anche rinunziare a intendere a pieno il suo caso morboso, perché quello che è minato dal fine a cui si mira e che si raggiunge e che perciò si ripercorre e s’intende, ma una mancanza di fine e una effettiva stasi.
In conseguenza della grande importanza che egli attribuisce all’articolo mallarmiano del 1862, il Noulet è preso da scrupoli nell’accingersi a commentare i dieci poemi che ha scelti, perché con simile lavoro che allarga pericolosamente la cerchia dei lettori del Mallarmé, si viene ad operare in senso contrario alla fede professata e raccomandata dall’autore. Ma egli risponde a sé stesso che le esegesi del Mallarmé sono lette meno della sua poesia, sicchè il pericolo non c’è, e che al sua esegesi non vuole conquistare nuove anime, ma «ha di mira soltanto di rafforzare la fede di coloro che la posseggono già, e moltiplicare le ragioni dell’ammirare in coloro che già le hanno»; e, quanto tutt’altro manchi, «si può forse impedire al fanciullo d’inventare e all’occhio dell’uomo di frugare il cielo che egli contempla?». La risposta è un po’ stupidina. Ma tutta questa illogica è, per un altro verso, a suo modo, perfettamente logica, perché se quella che il Mallarmé chiamava poesia non ha nessuno dei caratteri della poesia di tutti i secoli precedenti ed è diversa da tutto ciò che risponde all’idea della poesia elaborata dal pensiero di almeno due millenni e mezzo, e se essa non vuol essere l’espressione armonica della vita spirituale negli infiniti suoi modi di gioia e dolore, ma invece è direttamente vita essa stessa, avvolgendosi in sé e di sé eccitandosi, ed esce in suoni che non creano immagini, ma occasionano un oscuro, un cieco movimento in chi l’ascolta, è evidente che nessun commento se ne può fare che non sia arbitrario, e che si deve, in ultimo, domandar perdono per aver osato ciò che chi lo fa sa e stima anche lui che sia proibito. Il lettore non addomesticato a cotesta logica-illogica e non domato dalle martellate di codeste frasi senza senso, si domanda, da povero uomo qual è: - O che si canzona? – Ma il sublime iniziato tira superbo e raccolto in sé per la sua strada. Tuttavia recherò qualche esempio di quel che fa il critico e che egli è incerto come definire, perché non vuol sapere di trattare quella che chiama «opera strana» mercé di una «semplice parafrasi prosaica» o congiungendola alle correlative teorie nuvolose, e dichiara che limiterà il «sacrilegio della sostanza stessa del pensiero mallarmiano» col rifiutare di ricavarne il «valore figurato» e col dare di esso una «spiegazione letterale e letteraria». Come che sia, tolgo a saggio di quanto ci si offre intorno all’opera di Mallarmé scegliendo tra i dieci poemi il nono, che il Noulet stesso afferma appartenente a un’epoca nella quale il Mallarmé, venuto in possesso di tutti i suoi mezzi tecnici, non pubblicava se non in versi «definitivi e senza punteggiature», e che perciò esso «si situa al culmine del suo svolgimento».
Le due quartine del sonetto sono queste:
A la nue accablante tu
Basse de basalthe et de laves
A même les échos escalves
Par une trombe sans vertu
Quel sépulchral naufrage (tu
Le sais, écume, mais y baves)
Supréme une entre les épaves
Abolit le mât devêtu :
le quali – dice il critico – formano una «frase sola, sinuosa, in arabesco, i cui movimenti ben convengono alla figurazione di un naufragio», con la congiunta dispersione delle funzioni grammaticali, che è «disordine intenzionale e rispondente a una visione imitatrice». C’è, invero, già nel primo verso un incaglio, quel «tu», che sconcerta il lettore, il quale va dritto al «tu» pronome, laddove quello è il participio passato del verbo «taire», e il Mallarmé, per costringere a non attaccarsi indebitamente ad «accablante», e per introdurre una pausa, ha qui moltiplicato le difficoltà e ha reso, come egli voleva, quasi impossibile la pronuncia del verso con la penosa successione delle dentali e con altri avvedimenti. Ma a che si riferisce il tu, il taciuto? Al «naufrage» del primo verso della seconda strofa, che è il «soggetto delle due quartine e la base dell’allegoria»; naufragio, cioè taciuto alla nuvola, la quale, «con l’opposizione di bassa, di basalto e di lave, imita il peso nero di una nuvola bassa»; alla nuvola la cui tromba era «senza virtù», e perfino priva degli echi suoi schiavi. Viene un secondo «tu», che questa volta è il pronome, posto fra parentesi in vista, si direbbe, per rendere più ermetico ancora il primo o per creare l’equivoco mercé estravaganti associazioni d’idee. «Mallarmé aime ces sortes de pièges», dice il Noulet in altra occasione; né il senso di questa avvertenza si lega all’idea o simbolo del poema, ma allude alla necessità dovuta alle difficili rime in «aves», e tuttavia ci dà la «descrizione completa e morale della schiuma, che è il solo effetto e il solo testimone del disastro». Il «supréme entre le épaves» ci avverte che tale doveva dirsi tra i rottami l’albero maestro della nave, e l’«abolir», è un bel retaggio che il Mallarmé ricevé da Gerard de Nerval e che perciò ebbe sempre cara.
Le due terzine suonano:
Ou cela que furibond faute
De quelque perdition haute
Tout l’abîme vain eployé.
Dans le si blanc cheveu qui traine
Avarement aoura noyé
Le blanc enfant d’une sirène.
Anche queste due terzine compongono una sola frase tumultuosa. Quell’«ou» è un dubbio o un’interrogazione, e vuol dire che l’abisso che, in mancanza di una preda di valore, ha annegato qualcosa di poco pregio e di scarsa consistenza, in un verso singolarmente e fortemente tagliato, in cui domina il «furibond», come se si sentissero e si attendessero i colpi della massa dell’acqua sul guscio della nave in pericolo; e l’ultimo verso della prima terzina e il primo della seconda compongono la descrizione del mare sfrenato, la cui ira non riesce ad altro che alla frangia bianca di schiuma sulla cima delle sue onde. Che cosa, infatti, ha divorato l’avido mare? Nient’altro che una creatura chimerica, e neppure questa, ma il semplice suo «fianco». Tutto il peso del cielo (prima strofe), tutta la violenza del mare (seconda e terza), tutte le forze unite del vento e dell’acqua non si sono indirizzate ad altro che ad annientare ciò che esiste appena, la forma intraveduto di un mito nascente. E’ ancora, nel Mallarmé, quel poema di disperazione che simoleggia l’ingoiamento di ciò che non è mai stato. Somiglia alla caduta di Icaro del Breughel, dove un punto rosa sparisce, una disperazione isolata sprofonda nei flutti e nel tempo.
Confesso che, nel leggere queste intenzioni del Mallarmé e queste spiegazioni del suo esegeta, mi girava insistente nel ricordo la battuta di una commedia cinquecentesca (l’Ortensio, attribuito al Piccolomini), nella quale un napoletano, vantatore della sua ingegnosità in amore, mostra una medaglia da lui fatta incidere per una corteggiata signora Leonida, e ne spiega le figure e le allegorie: «Chisto è no vosco, chesta è una sepe, chiste songo lazze pi pegliare l’anemale, chiste doi leoni che, iettatome nterra, devorano lo mio core, e vo’ dicere: Leoneda, chesto è lo meo cor devorato»: al che il suo servitore, che ascolta, commenta tra sé con un altro «chisto», definendo acconciamente il suo padrone. Mi si perdoni l’associazione d’idee, che non vuol offendere nessuno, ma accusare un procedimento poetico o esegetico che sia. Certo, a quel modo quella medaglia non parlava da sé con l’evidenza della sua bellezza.
Ecco determinato alfine – conclude da sua parte il Noulet – il tema proprio del poema, «che si può gonfiare di tutte le interpretazioni personali e di tutti i simboli più lontani. Ma a questi secondi significati esso opporrà ormai la sua propria resistenza, le sue proprie prospettive, perché dietro di esso si vede profilare il sogno immenso del poeta, l’opera-sintesi, che avrebbe potuto dare scacco matto all’accidente, il libro unico, espressione totale del mondo. Qui, cosa ancora più commovente, si sente sorgere il lamento, che si rinnovella, dell’impotenza creatrice».
Il critico, dunque, ammette (non senza contradizione con la sua professata impossibilità d’interpretazione) che vi sia differenza tra un poema, che in quanto tale ha il suo senso, e le estranee personali interpretazioni che apportano i lettori del poema. Ma come dimostra che il significato da lui affermato sia, non diciamo voluto dal Mallarmé (perché in poesia il «voglio» non vale), ma intrinseco alla poesia, che non sia allegoria, ma fantasia che parla da sé e a cui l’allegorizzazione rimane sempre aggiunta estranea? Perché di questo si tratta: egli potrà possedere un documento di pugno del Mallarmé e non proverà nulla, se la poesia non esprime direttamente l’impressione di un sogno che si va spegnendo senza che sia stato raggiunto e la disperazione dell’incapacità a più raggiungerlo. Ma il complesso di parole e di rime che il Mallarmé ci ha messo innanzi, nonostante i concimi ermeneutici del Noulet e le indulgenze per le necessità della rima o per l’assenza (con un’unica eccezione) di punteggiatura, manca della profonda chiarezza ed univocità che è della poesia, e resta muta se dall’esterno non gli si mette sulla bocca un qualche sentimento o pensiero, per stravagante o insulso che sia.
Mi astengo dalla facile ironia su codesti sforzi del Mallarmé e dei suoi commentatori per farci sapere ancora una volta che egli dinanzi all’ideale pazzesco del «Libro unico e definitivo» da dare al mondo, era un «impotente», o conferire un che di tragico e di sublime a questa condizione, se non ridicola, certamente mortificante. E voglio anche escludere che il Mallarmé e i suoi devoti siano, come è stato talvolta sospettato, consapevolmente ciarlataneschi, ingannatori di altrui; ma non posso escludere che ingannassero o che ingannino sé stessi, come accade nelle fedi che l’intelletto non ha generate e che non può convalidare, e che pure quaerunt intellectum, e finiscono col lavorare, verso loro medesime, di simulazione e più ancora di dissimulazione. La realtà che rimane in tutto ciò non è la poesia, ma il fatto che, nell’ultimo mezzo secolo e ancora nel presente, molti accolsero questa fede; il che appartiene, senza dubbio, alla storia dell’età e dei suoi travagli e delle sue manie, ma non alla storia della poesia.



 Pubblicato 15 anni fa #
Pubblicato 15 anni fa #
 Pubblicato 15 anni fa #
Pubblicato 15 anni fa # Pubblicato 15 anni fa #
Pubblicato 15 anni fa #