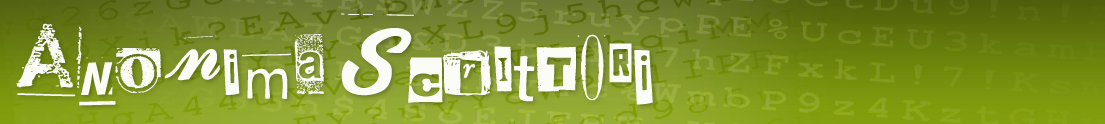Cronache da un pianeta abbandonato - I capitolo - Il circo
Categoria: ...Altro, Cronache da un pianeta abbandonato, Progetti
Postato da: zaphod
Karel
Il circo si piazzava sempre dietro i portici dell’Intendenza a modificare ogni volta l’immagine dei mondi da noi conosciuti. Dietro quei portici – quel colonnato altissimo, imponente, con ancora impressi i simboli del passato regime e dietro i quali si sarebbe dovuta espandere la colonia, la gigantesca testa di ponte per il nuovo Balzo in Avanti – c’era per noi quotidianamente il nulla: solo lo spiazzo da cui spuntavano ogni tanto, frammisti a ciuffi d‘erba, i ferri arrugginiti e il cemento dell’erigendo, tanti anni fa, mercato coperto. Poi più niente, eccetto la piana interminata dei deserti e le nubi di polvere – quando s’alzava il vento – a scacciare da quello spiazzo anche le bande di ragazzini che si affrontavano a mazzafionda dopo la scuola. La notte solo – la notte, quando i soli calavano, ma prima che s’alzassero le lune, in quel breve ed unico intermezzo buio – tutta la colonia si ritrovava in piazza in un non detto, padri e figli, in un appuntamento mai fissato; con gli occhi dritti a rimirare, dietro i pilastri del colonnato, i mondi lontani e qualche raro estraneo passaggio di navicelle spaziali: “Chissà dove andranno”.
Erano anni che non atterravano più cargo regolari. Neanche la posta, neanche le notizie. La “Gloriosa Ricerca” – come s’era detto allora – “del mare di galassie che pur dovevano esserci oltre i Cieli del Buio e che aspettavano solo Noi”, era per sempre rimandata. Caduto il regime, caduta la Ricerca. E con essa la colonia. Niente più arrivi. Niente più invii. Si apriva una volta l’anno – alla congiunzione di Gagarin-2 con Unamuno-24 – lo spazio di un’ora per le comunicazioni con la deputazione più esterna della Federazione, ed in quell’ora facevamo incetta di soap, film e tg da rivedere tutto l’anno. Poi più niente, neanche un mercante o un contrabbandiere scalcagnato. Solo – ogni tanto – un circo. Ci alzavamo la mattina e vedevamo all’improvviso, di là dai portici dell’Intendenza, il tendone già montato che sbarrava il passo alle nubi di polvere ed ai venti del deserto.
Mio padre mi ci portava la sera stessa, tenendomi sempre per mano, con la camicia pulita e i capelli lisci di brillantina. Giravamo prima attorno al tendone, a guardare le gabbie delle fiere e gli inservienti che risaldavano lastre – al limite delle sabbie e dello spiazzo – sullo scafo malandato. Poi entravamo tra i suoni dello spettacolo e restavo tutto il tempo lì – con gli occhi sbarrati e con la mano sempre nella sua – a sognare il vero mondo, la vera vita: “Da grande andrò via anch’io con il circo”. Neanche m’accorgevo che il lanciatore di coltelli era sdentato, gli orsi di Vega-7 spelacchiati e la Venere di Orione-3 – danzante sul trapezio – aveva le calze a rete sfilacciate. Me le faceva notare lui, mio padre, nel ritorno, ridendo. E io ritraevo la mano.
Oggi non porto mai mio figlio al circo, quando arriva in colonia. Vado da solo. E se la trapezista ha le calze bucate, risento ancora la mano di mio padre nella mia. Dopo il numero però vado dietro il tendone e, spesso, per 30 crediti gliele tolgo io. Le sfilo pian piano, accarezzo quei buchi e poi la bacio tra le gambe sudate. Lei si piega tra le gabbie delle fiere su di un plinto del mercato, inarca i muscoli duri per reggersi, come sul trapezio, ai ferri del cemento mentre, prima di prenderla, la ribacio da dietro. Ai lumi delle lune si vedono, da sotto, i seni dondolare.
Torno a casa da mio figlio che dorme dalla signora di sopra. Lo porto giù in braccio senza svegliarlo. Gli lascio le liquirizie vicino al cuscino. Vado in camera mia. Sul letto grande. Da solo. Ad aspettare che arrivi di nuovo il circo.
Erika
M’è toccato chiudere la bancarella e riportarmela via. Era venuta proprio Ursula a dirmi: “Hanno ragione loro”.
“Sì, padrona”, le ho fatto. Ed ho obbedito.
M’ero portata proprio tutto: liquirizie sia gommose che dure – lunghe e corte – arachidi, nocciole, semi tostati e salati, ceci, lupini, mandorle caramellate, torrone ed amaretti. A destra della bancarella avevo sistemato la macchinetta per lo zucchero filato e nel cassetto pensavo di mettere i soldi come faceva mia suocera. Ogni volta che lo apriva ricontava sia gli spicci che i biglietti, poi segnava tutto su un foglietto che riponeva nel reggiseno: “Una volta con il circo si facevano dei soldi”, diceva lei. Ma a me m’hanno cacciato: “Lo zucchero filato ce lo facciamo noi. Che ci siamo venuti a fare allora fin qua?”
“Ma chi vi ci ha voluto”, gli volevo rispondere: “Statevene a casa vostra”. E invece è arrivata Ursula. M’è toccato ricaricare tutto sul carro e tornare al negozio: “Domani sera però ti spezzo, in palestra”.
Lui stava come lo avevo lasciato: seduto al tavolino vicino all’entrata, con la mano destra poggiata al bastone e lo sguardo fisso oltre la vetrina – senza dire una parola – esattamente come suo padre quando eravamo bambini. Lui gli si metteva vicino a rifarne già le mosse e – come lui – si muove di lì adesso, qualche volta, solo per spostarsi in veranda, con la sedia attaccata al vetro. Da piccolo stava sempre sull’ultimo scalino, con i gomiti sulle ginocchia e i pugni chiusi sotto il viso. Ma di che mi sarò innamorata?
Passo le giornate a tentare di parlargli da dietro il bancone: “Allys, mi senti? Essì che mi senti. Allys, mi passi quel bicchiere? Allys, mi senti? Ma parla almeno a tuo figlio”.
Niente. Un muro che non risponde. Quando gli porto una grappa, mi fissa qualche volta negli occhi, mi scava dentro fino a turbarmi la coscienza e si rimette a fissare il vuoto. La gente viene, beve, fa, ride, compra e scherza come se lui non ci fosse. E noi non ci siamo per lui.
Solo Martin il giornalista si informa. Mi chiede come sta, mi chiede se parla e se mi ricordo della madre di Allys.
“No”, vorrei rispondergli ogni volta, “non mi ricordo di mia suocera”.
E invece gli rispondo “Sì” e lui va avanti con i ricordi suoi. Dice che fa il giornalista, ma come vuoi che campi il giornalista di un foglio mensile di una colonia così piccola che tutti sanno i fatti di tutti ancora prima che succedano? E lui infatti deve andare a giornata.
Chi gli dà ogni tanto qualcosa da fare è Foost il fabbro, quando deve forgiare pezzi grandi e gli serve per forza una mano alle pinze. Ma succede di rado e chi deve mantenere la famiglia è la moglie, povera Sophie, che deve andare tutti i giorni – tra un vestito e l’altro – a fare i servizi a casa del Giudice. Lui – il giornalista – tra figlie, figli, operai e apprendisti di quel taccagno di Foost, deve sperare solo in un’epidemia perché lo chiamino più spesso. Così si adatta a tutto – dice lui – va a fare il bracciante nelle fattorie, pulisce le erbacce dalle strade, ma soprattutto sta in giro per i bar. Soprattutto il mio. A chiedermi ogni volta se mi ricordo di mia suocera. Uno zingaro. Come quei maledetti del Circo.
Però Martin è l’unico che ordina due grappe – se non ha i soldi dice “Segna!” – le porta al tavolino, si siede davanti ad Allys, gliene allunga una ed inizia a parlare della vecchia miniera abbandonata e delle gallerie dove solo loro due sarebbero penetrati da piccoli. Ma quando mai? Allys che si alzava dai suoi scalini?
Lui lo sta a sentire con lo sguardo sempre fisso al di là della vetrata fino a che – andando via – Martin dice: “Ma prima o poi lo troviamo, io e te, il filone nuovo”.
Allora sorride e gli esce, in un fruscio, un “Ciao”. Basta.
Foost
“Che dici, usciamo a fare un giro?”
“Ma non rompere le balle, esci tu se ti va, io ho da lavorare”. E anche la vecchia è sistemata.
Compiuto il mio dovere – le pasticche di Stavrakopoulos fanno miracoli – tiro su la lampo della tuta e vado in officina. La signora si lamenta ma lo sa – alla fine della fiera – che se ha una bella casa, veste bene e il piatto in tavola non manca mai, è perché c’è un cretino col saldatore e la fiamma ossidrica in mano per tutto il santo giorno. Altro che uscire. Certo a lamentarsi che la vita è dura sono buoni tutti, ma dopo cena non senti un martello picchiare in colonia. I bicchieri sì che tintinnano, e i fiori si debbono andare a nascondere. Prova, magari, a chiamare qualcuno per un lavoro. Ti mandano lo sceriffo a perseguirti a termini di legge. Sta sempre qui a rompere le scatole, gli venisse un colpo: “Questo non va e questo nemmeno, le norme della sicurezza, il lavoro nero, il lavoro minorile”.
Ma che te ne importa a te? Sono figli tuoi? No, sono figli e nipoti miei. Permetti che li faccio lavorare come pare a me? Poi però – quando gli si rompe il furgone della polizia o bisogna rifare l’avvolgimento ai rotori dei camion e delle autobotti della guardia – mica sta a guardare che a smaltare i fili o a trafilare il rame ai banchetti ci ho messo i miei nipoti, invece di mandarli a scuola. Ah, allora è tutto un “Foost si sbrighi, Foost la prego: è un servizio che fa alla Colonia”? Gli venisse un colpo anche alla colonia. Perché non se la va a prendere con gli storditi dai fiori, invece di rompere le scatole alla gente per bene come me, che lavora e che produce? Non sono più i tempi di una volta. No, mi stanno pure a razionare l’energia: “Foost, consuma troppo”. E come li rifondo i metalli io, con la forza del pensiero? Mi hanno preso per l’illusionista del Circo? Forni e laminatoio li mando avanti a bestemmie o preghiere? Chiamassero pastore Jacob allora.
Lei dice: “Usciamo!”
Ma ti venisse un colpo pure a te, dove vuoi che usciamo? Io posso uscire solo per andare a cercare metalli. Ma che non lo vedi che non c’è più un grammo di ferro in colonia? I figli si occupano solo di meccanica fine oramai, il lavoro sporco non gli interessa più. Voglio vedere come faranno il giorno che non ci sono più io, mi voglio fare quattro risate. Chi gliele va a cercare le materie prime? Pastore e sceriffo?
I vecchi – quando ci mollò la Federazione – trovarono un paio di filoni di ferro, misto a carbone e rame. Ma era poca roba e i pozzi si esaurirono subito. L’unica mia miniera è sempre stata l’astroporto. Quello la Federazione – anzi, il passato regime – lo fece in grande stile: chissà quante navi ci sarebbero dovute passare. Un po’ alla volta l’ho smontato tutto. Avevano già iniziato mio padre e mio nonno. Ho finito io. Tutto rifuso e riciclato. Ma non c’è più quasi niente, mentre il reattore – esauritisi pila e superconduttori una trentina d’anni fa – bisogna aspettarne almeno altri trecento per poter pensare di andarlo a toccare.
Restano solo le fondazioni dell’astroporto – estraggo il ferro dal cemento, altro che “uscire” – e l’unico che mi dà una mano, ogni tanto, è quell’altro stordito di Martin. Mai visti un occhio e una mano così – un genio – anche ogni nuovo lavoro gli viene naturale come il respiro. Gli ho chiesto un sacco di volte di entrare in società. Con lui l’azienda farebbe un affare. Ma non vuole. Dice che – a parte che non vuol fare sgarbi ai miei figli – non è il suo mestiere. Lui fa il giornalista – “Il giornalista qua?”, gli dico sempre: “Ma che stai, su Betelgeuse-4, ti venisse un colpo?” – e viene da me solo quando è alle strette. Deve “uscire” pure lui, tutti che debbono uscire in questa cavolo di Colonia – “Usciamo?” – e poi la baracca va a rotoli.
“Esci tu, disgraziata, non vedi che ho da lavorare per tutti?”
Brown
L’altro giorno non siamo andati a scuola. Troppo sole ci chiamava là fuori – al di là dei campi di steli – nel letto dei canali asciutti, punteggiato ogni tanto da macchie di eucalypti.
Haccious è stato il primo a tirare fuori la mazzafionda. Ne ha una nuova da caccia, nera. Io e Myrna abbiamo ancora quelle rosse, con le strisce di camera d’aria di bicicletta. Lo abbiamo guardato con invidia e ci siamo messi a cercare grillo-topi.
Ne abbiamo trovato uno solo, già morto. Bastava però come bersaglio ed io ero anche più contento. Non mi piace uccidere gli animali, anche se schifosi come i grillo-topi. La gara è finita quando il cadavere non c’era più, disintegrato dai loro colpi. Myrna ha una mira che fa paura – anche Haccious non scherza – mentre io non colgo un passero ad un metro, anche se poi dico che lo sbaglio apposta. Certe volte col sasso mi prendo proprio la mano che regge la forcella. Sono sempre pieno di lividi e – quando torno a casa – mia madre li vede e mi dà il resto.
Abbiamo poi preso a gironzolare tra i canali parlottando di Galaxy-League, sempre con il cane di Myrna dietro. Appena la chiama – “Laika!” – corre subito e fa tutto quello che le ordina. Lei dice che è più intelligente di me. Ma il guaio è che lo dice pure Haccious – e Myrna ride – perché continuo a tifare Vega-7 nonostante le mazzate prese l’anno scorso dal Manchester Planet. Ma quella è la mia squadra: io tifo Vega la magica perchè da lì venivano i miei, giallorossi da generazioni. Mica come lui che ogni anno cambia e si mette col più forte: “Io voglio vincere” dice, e allora anche Myrna si arrabbia e lo sfotte. Io gongolo e riprendo coraggio, anche se so che preferisce lui: non la vedo forse – quando giochiamo a fidanzati – dargli sempre più bacetti che a me? E neanche fiata quando prende a calci Laika, lo guarda solo storto. Haccious da grande – se non scappa con il Circo – dice che farà il Giudice. “Delinquente com’è”, dice la signora Erika, quella stronza del bar, “capace pure che glielo lascino fare”.
Stavamo per litigare quando Laika all’improvviso s’è impuntata. Myrna le si è accucciata a fianco e ha fatto segno di abbassarci e tacere anche noi. Da un canalone via l’altro eravamo arrivati – passando dai campi coltivati fin dentro il folto della foresta scura – nei pressi del capanno di Perfido Blackman.
Noi non lo avevamo mai visto, né lui né il suo capanno. Ma ne avevamo sentito parlare fin dall’asilo. Perfido Blackman è il diavolo in persona. Vive solo. Non si fa mai vedere da nessuno. E’ uno stregone. Mette paura a guardarlo. E chissà cosa fa ai ragazzini.
Io volevo scappare subito. Haccious pure, secondo me. Myrna invece s’è messa a strisciare – col cane che le strisciava dietro pure lui – e abbiamo dovuto proseguire anche noi.
Sgusciando tra rovi e cespugli – nel buio del sottobosco muschioso, velato da stuoli di ragnatele – siamo sbucati nel sole di una piccola radura coltivata. Filari di piante con foglie altissime – che si levavano dal terreno – che non avevamo visto mai. Altro che steli di luce. Tutta roba marrone.
In fondo alla radura – con alle spalle di nuovo la foresta – un capannone di lamiera malandata: “Se lo vede Foost lo smonta al volo”, ha detto Haccious. Di qua e di là dal capanno una sfilza di pali a mezza altezza da cui pendevano – come le pelli di Brain, quando trova qualche bestia ammazzata – le foglie morte di quella strana pianta messe giallastre ad essiccare.
S’è aperta – “Scrèèèk” – una porta dal muro di lamiera. E’ apparso Blackman poggiato ad un bastone. Alto. Enorme. Giacca scura. Camicia fuori dai pantaloni. Cappello di paglia. Baffacci bianchi. Occhiali calati sul naso. Sguardo torvo. Ed un ghigno satanico stampato sul viso.
Siamo scappati di corsa: “Ahùùùùùù”, faceva Laika al galoppo davanti a tutti.
Myrna rideva.
Yu
Non c’è riunione del Consiglio in cui non faccia presente che mi sono finite le penne. E la lavagna è tutta rovinata. E i gessi colorati non sono abbastanza. Non parliamo dei videochips e della similcarta. Spero che prima o poi mi rispondano. Questa volta debbono farlo.
Vivo nella biblioteca. Tutti i giorni, tranne il martedì, la tengo aperta dopo le lezioni. La tengo aperta anche la domenica. Chi non va dal pastore viene qui a giocare a carte. Non tutti la usano per leggere, la biblioteca. Ma io no. Dentro ci studio, preparo le lezioni, custodisco, archivio, scrivo la storia della colonia, faccio il professore, il maestro, il bidello e solo a notte fonda salgo nelle mie stanzette.
Il martedì zappo l’orto, o vado a cercarmi un po’ di legna per l’inverno a Monthel Hill. I libri li amo, stanno in scaffali alti e polverosi, offrono la loro fidatezza a chiunque ne voglia. Non abbiamo nessun libro raro nella nostra biblioteca, questo il Giudice lo sa. Ma quelli che ci sono, ci bastano e avanzano. Ogni tanto gli chiedo di poter stampare qualche titolo nuovo dai file archiviati ogni anno. Ma lui non risponde mai. Alza solo le spalle.
E’ lui che comanda in Colonia. Non farebbe nemmeno parte del Consiglio. E’ il Giudice e basta. Ma lo invitano per deferenza ad ogni riunione – “Per consulto”, dicono – e lui parla ogni volta ed ogni volta alla fine conclude: “Però questo è solo il mio modesto parere, poi è giusto che facciate solo quello che decidete voi”. E loro decidono sempre quello che ha detto lui. Altro che separazione dei poteri – legislativo, esecutivo e giudiziario – come recitano gli statuti fondativi di ogni colonia che si rispetti. Altro che conflitto di interessi: “Quis custodiet custodes? Io resisto!” gli ho detto l’ultima volta, prima di abbandonare la riunione.
“Lei resiste? E’ la colonia, qui, che deve resistere!” mi urlava dietro per le scale e poi fino in fondo all’altro lato della piazza: “Lei non ha idea di quanta energia ci vuole per produrre tutte quelle penne, matite, gessetti, libri, dvd, similcarta, videochips che le diamo a iosa e che lei spreca come se niente fosse”.
Così quando arriva il circo vado ad elemosinare che mi lascino perlustrare da cima a fondo tutto lo scafo alla ricerca di ogni pezzo di carta – pure Harmony o Pornogalaxy, quello che trovo trovo – e passo i mesi in biblioteca a restaurare e portare tutto a nuovo. Mi piacciono i libri e mi piace guardare la gente che legge. Quando resto solo, prendo i volumi, li annuso, li carezzo e talvolta mi addormento tenendoli tra le braccia. Qualche libro lo leggiamo insieme, passandocelo a turno, nelle classi serali. I grandi hanno più interesse dei piccoli e a loro non debbo dire “Stai buono, non parlare, non interrompere”. Ma anche i piccoli mi divertono; gli adolescenti non esistono più: qui si passa subito dalla fanciullezza all’età adulta.
“Veda di farne buoni tecnici, buoni agricoltori, ingegneri, medici, scienziati. Questo ci serve. Sennò vada a tagliare la legna nei boschi”, mi ha detto il Giudice a nome del Consiglio. E io questo cerco di fare. Non sono un visionario, non faccio niente di diverso: su questa colonia sperduta non sono né il primo né l’ultimo. Sto nella massa. E insieme agli altri la faccio lievitare. Sono un professore. Resisto con la mia colonia attraverso l’educazione.
Ma qui comanda il Giudice e tutti gli dobbiamo obbedienza. Siamo i Suoi pensieri. I Suoi personaggi. E forse ci stiamo pure bene. E’ il nostro dovere. Ed è tutto ciò che possiamo fare.
I boschi? Io ho le mani deboli, ma la voce è squillante quando faccio l’appello. So distinguere un sorriso forzato da uno naturale, tra i miei lettori e studenti. E carico sempre il mio orologio a molla, per aspettare il Messia.
Sempre che non me ne vada anch’io con un primo circo di passaggio.
Angie
Ogni mattina accendo il sistema automatico.
Lui segnala sempre punti in cui ci sarebbero anomalie.
Lo spengo subito senza tenerne conto. Ne so più io.
Raggiungo i campi di luce quando il Primo Sole è appena spuntato – si sente già Zacharias battere in officina o dare sulla voce a qualche bestia – e controllo i rapporti di funzionamento. Passo tra i filari, guardo di fianco ogni tanto sui fiori e provvedo.
Tutte le fattorie della Colonia hanno i campi di steli. Noi il Campo di Luce perché da bambina una volta – camminando vicino a mio padre ed era mezzogiorno e tutte le corolle puntavano verso di noi ed avevamo il Primo Sole alle spalle ed il riverbero era accecante – sembra che io abbia detto: “Papà, un campo di luce”. Si mise a ridere, e quel nome è poi rimasto.
La mia prima ora di lavoro è sempre lì. Il programma di manutenzione darebbe pure delle indicazioni di massima, ma anche lui non sa niente delle buche lungo il percorso, della rugiada che di mattina impedisce i movimenti o dei riverberi, appunto, del sole, quando i calici degli steli sono puntati verso di me. A volte l’anomalia è talmente nascosta che devo smontarlo lo stelo, sfilarlo dal terreno dopo avere disconnesso il microchip dalle radici, sgranare uno ad uno i microspecchi di silicio dalla corolla per verificarne il funzionamento, controllare il convogliatore termico, riposizionare la corolla in maniera che i paraboloidi convergano tutti sul convogliatore e infine rinnestare lo stelo, direzionandolo al millesimo di grado verso il Primo Sole perché riprenda il suo movimento all’unisono con gli altri. Poi passo sui campi che ci danno veramente da mangiare e – qui – ci torno solo a sera.
Prima che tramontino i soli ritorno ad ispezionare gli steli come faceva mio padre. Lo trovavo sempre avanti e indietro tra i filari a strappare erbe infestanti, lucidare corolle e controllare allineamenti: “Ma non converrebbe”, gli dicevo, “piantare solo mais e foraggio, e costruirci magari un nuovo distillatore?”
Neanche rispondeva. Strappava un altro ciuffo di gramigna e – mentre già si voltava per incamminarsi verso casa – mi faceva vedere come si smonta e lubrifica, a regola d’arte, un pulvino microdirezionale.
Il campo di luce però – esattamente come allora – basta giusto a produrre l’energia per la quota fissa da dare alla Colonia. Poco di più, nella bella stagione. Riesco appena ad illuminarci casa e a ricaricare il furgoncino per poterci andare – una sera ogni tanto a settimana – in palestra a combattere con le mie amiche. Pure il pozzo lo debbo mandare avanti con la pompa a vento, anche se con l’acqua non irrigo solo gli altri campi – quelli che ci danno da mangiare – ma anche e soprattutto gli steli. E la sera – solo la sera però – devio il flusso dell’acqua tutto su di loro. Zacharias dice che ci vorrebbe un altro pozzo.
Il campo di luce è affare mio. Lui lo chiamo solamente quando c’è da saldare i rivestimenti metallici degli steli, spezzati di notte da un uragano. Sarebbe un ingegnere – “Ho la laurea!” dice – ma sa fare anche da fabbro e da meccanico. S’è costruito un’officinetta – “Un laboratorio!” dice lui – un po’ più indietro dei silos del grano e lì ripara, dice sempre lui, gli attrezzi e gli arnesi della fattoria. Il pomeriggio – dopo che ha finito i lavori in stalla e negli altri campi – lo lascio quasi sempre andare dai vicini che lo chiamano in continuazione, per qualche macchinario da aggiustare o un pezzo da risaldare.
Non c’è mai, a casa.
Torna di corsa al primo imbrunire – perché sennò lo sa che poi m’arrabbio – per fare al volo la mungitura serale, mentre io sto ancora al campo di luce ad inzuppare d’acqua il terreno perché le radici esprimano tutte le bioenergie necessarie alla fotosintesi cloroelettrica.
E’ Paul – il primo maschio, sedici anni oramai – che mi viene sempre a chiamare: “Ma’, è buio”.
Jacob
Due settimane che il circo è partito eppure qualche illuso ancora sosta davanti allo spiazzo, lanciando occhiate furtive con la speranza di essersi sbagliato: “Magari il tendone è sparito solo per un attimo con tutti i suoi abitanti, e per magia adesso torna”. Ma l’unica magia che gli rimane sono i riflessi del tramonto nei mulinelli di polvere, spettri rossastri di quella provvidenziale sparizione.
Un uomo chiede quando tornerà. Senza guardarlo gli urlo: “Il più tardi possibile, che il diavolo se lo porti”, e poi mi volto. E’ Smithson. Conosco tutti, qui. Gli ordino di filare subito a casa a pregare per i suoi peccati.
Mi guarda con gli occhi lucidi, ma si incammina. Barcolla. Ha una gran sbronza da smaltire, prima di potersi ripresentare alla signora Smithson. Quando mi verrà a salutare domenica, dopo il sermone, avrà dimenticato tutto.
La mia chiesa chiude la prospettiva del viale delle Costellazioni – così c’è ancora scritto sulla grande carta del piano regolatore, redatto a suo tempo dagli urbanisti della Federazione – anche se tutti dicono solo, oramai, “via della chiesa del pastore Jacob”. Il campanile si erge come lo gnomone di una meridiana e l’ombra adesso segna la mia casa, il piccolo edificio che gli sta di fianco.
Ylenia – quattordici anni – è nel piazzale terroso. Prova le acrobazie che deve avere visto fare – di nascosto – ai saltimbanchi di Deneb. Niobe ride. Guarda la sorella maggiore atterrare malamente e ne imita con una smorfia la riverenza.
“Peccatrici!” grido da lontano. Raccolgo da terra un bastone ed accenno due passi di corsa: “L’ira di Sabaoth sia su di voi”. Ma non faccio in tempo e già fuggono dietro casa. Iddio mi protegga, ma se quella continua così, la prossima volta me la portano via con loro.
Solo quando entro nel tempio – sicura che lì non la percuota – Ylenia si riaffaccia a dirmi che la madre e l’altra sorella più grande sono andate a cercare le erbe per Anikem, l’unico mio maschio di salute assai cagionevole. Sono anche venuti a chiamarmi – dice – e so già chi. La mando a prepararmi il calesse e prima di partire – “Farò tardi” – le assesto una frustata.
Attraverso la periferia immobile e silente. Qualche saluto. Arrivo alle case popolari. Entro in un appartamentino piccolo piccolo al piano terra – la porta dà sulla strada – neanche troppo pulito. Lei è sul letto. Un odore acre salta già al naso. La finestra è chiusa, quasi che l’anima – non trovando l’agio di uscire – debba per forza restare ancora qui. “Apritela, pagani!” urlo ai vicini venuti ad assistere. E li sbatto fuori.
Lei sul letto sussurra: “Bene arrivato, Jacobus”.
Più che la finestra, la mia vecchia maestra sembrava proprio aspettare me, per poter liberare la sua anima.
Invece non è stato semplice. C’è voluta tutta la notte – con la sua mano nella mia – a recitare preghiere di commiato. Ho sentito pure dalla strada, a un certo punto, il macinino di don Fidel rallentare – il prete cattolico, il papista: le riconosco tutte dal rumore le poche macchine – e ripartire non appena scorto il mio calesse.
Veglio pregando. All’alba la mano è fredda. Gli occhi spenti. Oltre la finestra aperta, gocce di pioggia cominciano a cadere.
Torno a casa che mia moglie è sveglia: “Perché le hai picchiate?” mi rimprovera. Il temporale fuori sta oramai infuriando.
“Per la verità ne avrei picchiata una sola”, spiego rassegnato mentre mi tolgo gli abiti bagnati, “e comunque non era una frustata vera, ho fatto solo finta, gliel’ho appena appoggiato sulla schiena il frustino”.
“Ma che male c’è se giocano al trapezio?” insiste lei.
“Basta! C’è il demonio nel circo”.
“Ma quale demonio”, ripete querula: “Sei tu che vedi il male dappertutto”.
“No, sei tu che sei una santa e non riesci a vederlo da nessuna parte. Ma lo sai che succede alle trapeziste dopo il numero?”
Dolly
Le mani lunghe e curate – lo smalto lucente sulle unghie – stringono ancora lo straccio per la polvere. Mi chiamo Dolores – anche se tutti mi chiamano Dolly – e l’immagine che mi rimanda lo specchio dell’ingresso è quella, tutto sommato, di un bel corpo femminile.
Sempre – come per un gesto automatico – davanti ad ogni specchio sollevo la mano ai capelli e aggiusto i riccioli castano chiaro, frutto di ore e ore serali con beccucci e bigodini.
Ho un fisico asciutto, alto e slanciato che l’abito ospedaliero fascia – credo – abbastanza degnamente. Prima di uscire ritocco il rossetto, una vernice 80 gloss contro i ruvidi baci di mio marito. Sembro la classica infermiera dei telefilm di quarant’anni fa. Ma è su quei telefilm che da bambina ho costruito la mia idea di infermiera perfetta.
Lavoro da anni all’ambulatorio medico del dottor Stavrakopoulos e la notte scorsa ho aiutato a nascere il figlio della signora Moor, tre chili e quattro. Per arrivare all’ambulatorio da casa mia – di fianco alla piazza – debbo prima passare sotto i portici, poi voltare a destra e percorrere tutta la via della chiesa.
Un gruppo di ragazzini gioca a pallone nel piazzale, incurante delle erbacce – pastore Jacob le potrebbe pure tagliare – che invadono le aiuole. Quando si stufano del pallone, ci giocano alle tigri della giungla. I miei non ci sono.
Un altro stradone assolato dietro le scuole di palazzo K e poi – subito dopo la morgue, prima che la città finisca – il basso edificio che funge da ambulatorio: poche stanze le cui porte danno tutte sullo stanzone centrale, arredato per accogliere pazienti e visitatori.
Sedie pulitissime in tubo metallico lungo le pareti, con sedute e schienali di plastica stampata. Un banchetto come reception, stile ottant’anni fa – e non perché sia la mia idea di ambulatorio, ma perché qui non buttiamo mai niente, ritiriamo sempre tutto quanto a lucido – liscio davanti e con tanti cassetti dietro per le schede dei pazienti. In uno, anche un fornelletto di ferro smaltato per preparare il caffè al dottore. Poi poster con il corpo umano: gli organi principali, il sistema venoso arterioso, nervoso, muscolare e scheletrico; ma anche alcuni consigli preventivi, gli orari dell’ambulatorio, i numeri utili, una mappa stellare, le cascate di Betelgeuse-4, una veduta di Orione-3.
Su una parete s’apre il corridoio interno che, prima della morgue, porta alle sale diagnosi ed intervento dove non impera più, però, lo stile della Grande Ricerca. Qui è tutto perfetto ed operativo – seppure più in piccolo ed artigianale – secondo gli ultimi standard scaricati ogni anno: rivelatori subatomici, microchips endoscopici, chirurgia pararobotica. Il dottor Stavrakopoulos pretende che l’ingegner Mawrhapatthijya sovrintenda personalmente a manutenzione e aggiornamento di tutti i macchinari.
Alla manutenzione sua invece sovrintendo io, con il fornelletto smaltato. Non si è più ripreso da quella volta che non riuscì a salvare sua moglie. Ero qui da pochi mesi – fu il mio primo intervento morgue di sistemazione salme – e gliela feci trovare che sembrava viva. Non si vedeva niente. Ma è da allora che dopo l’ambulatorio – e spesso anche durante – passa gran parte del suo tempo al bar. C’è da pregare di non avere bisogno di un dottore certe volte in Colonia, se sono tutti come lui. Mi tocca andarlo a prendere – in caso di urgenza – lì da Erika, tirarmelo dietro come un bambino, sciacquargli il viso, imbottirlo di caffè, mettergli mascherina, camice asettico, bisturi in mano e, all’improvviso, s’erge sulle spalle, aggrotta lucido lo sguardo ed inizia ad operare come il profeta Isaia.
Aveva le mani lunghe – mi ricordo – e le misi lo smalto lucente. Le feci pure i riccioli con i bigodini.
“Li portava proprio come li porta lei, Dolly” m’aveva detto prima – tra i singhiozzi – lui.
Washington G.
Sdraiati sul letto fissiamo il soffitto. Tanija mi poggia una mano sul petto. Sospira. Ha voluto venire lei a casa mia. Me lo ha chiesto quando ancora il film era in corso.
Tutto intorno era buio. Le lune non rischiaravano ancora le strade. Dalla centrale di smistamento – per poter dare energia al megaschermo – avevamo razionato corrente a tutto l’abitato. Alle strade l’avevamo proprio tolta. Anche se non gliene diamo mai molta. Giusto un lampione su tre, e a basso voltaggio. Gli altri furono disattivati già ai tempi di mio nonno, quando la Federazione se ne andò.
E’ Nick che non è più riuscito a far partire l’iperconcentratore. C’erano voluti mesi per progettarlo, rigenerare i materiali dallo scarto, riadattarli, assemblarli in officina e collaudare il nuovo concentratore di energia. Stasera avrebbe dovuto fare il suo esordio trionfale – pensavo io – e la Colonia sarebbe rimasta illuminata, pure se poco, anche quando c’è il film. E invece abbiamo dovuto rispegnere tutto.
Ero stanco e amareggiato. Agitato, pure. E quando Tanija me lo ha chiesto, lì per lì non ho neanche capito. Poi volevo dissuaderla. Non volevo allontanarmi. Non in un momento del genere: “Aspettiamo che il film finisca. Se succede qualcosa, lascio Nick da solo?”. Lei però non si è arresa. E’ stata più esplicita. Ha insistito.
Non mi aveva mai chiesto, in questo modo, di andare a casa mia.
Mi sono guardato intorno. Tutti erano concentrati sull’ultimo capolavoro di Maresuke: con quella trama così complessa aveva catturato l’attenzione generale. Non si sentiva – contrariamente al solito – volare una mosca e la suspence degli altri ha fatto rilassare me, eccitato dal solo stare vicino a Tanija. Ho annuito, allora, e le ho sussurrato all’orecchio: “Va bene”. E’ scoppiata a ridere e qualcuno s’è pure girato.
“Guardati,” ha detto lei, “sei diventato rosso”.
Ero imbarazzato, sì, ma non per la proposta: c’era Nick che era troppo vicino – poteva sentire – e non m’andava che entrasse anche lui nella nostra intimità. Ma adesso che ci penso, se ha sentito è pure meglio. Dovrebbe essere lui l’imbarazzato, che ogni volta non fa che guardarle il culo.
Le lune sono alte adesso, e rischiarano da fuori il soffitto. Tiro un respiro profondo, voglio godermi questi istanti il più possibile. Dalla finestra entra una brezza fresca, una carezza lunga tutto il corpo. Guardo al polso l’orologio atomico del nonno di mio nonno, Washington G. Grant anche lui, come fece incidere sul retro. Sbuffo. Tra un’ora inizia il turno.
Tanija si riavvicina. Tiene il dito davanti alla bocca: “Lo senti il mare?” e tende l’orecchio.
Ogni volta che viene qui, ripete sempre questa cosa. Dice di sentire il mare, il rumore, e a volte perfino l’odore – la salsedine, secondo lei, portata dal vento la sera – nonostante stia ad una sessantina di chilometri. Di là dal deserto.
Le dico che è impossibile. Vivo in questa casa da anni – da sempre – ma non ho mai sentito nulla che potesse assomigliare al frangersi delle onde su di un bagnasciuga. E poi passi per il rumore – perché si sente spesso nei film – ma l’ultimo microchip olfattivo si ruppe più di cinquant’anni fa: “Che ne sai tu, Tanesha, di che odore può avere la salsedine del mare?”
“Sei proprio uno stronzo! E lo dici pure apposta: lo senti anche tu, ma non mi vuoi dare la soddisfazione”.
“Prima o poi ti ci porto”, fingo di prometterle mentre in fretta mi vesto; il turno smontante sta già aspettando il cambio in centrale.
“E come no?”, si riveste sarcastica anche lei. Nessuno è mai stato al mare. Che ci andremmo a fare? Qui c’è da lavorare.
La riaccompagno a casa. Per tutta la strada mi tiene il muso e non mi vuole salutare. Poi ride. E scappando dice: “Ma se lo chiedo a Nick, lui sona sicura che mi ci porta subito a vedere il mare”. E adesso vai a lavorare.
Sophie
La pioggia batteva insistente sui vetri.
Un tuono improvviso andava a coprire – di tanto in tanto – il rumore di sedie spostate e di stoviglie governate con malagrazia che veniva dal piano di sotto: i bicchieri tintinnavano un po’ troppo, oramai, per i miei gusti. Ho deciso però di non andare a controllare e di continuare col lavoro perché – se debbo interrompermi ogni cinque minuti – chissà a che ora finisco poi di rammendare.
Myrna ha bisogno di almeno un vestito in ordine da indossare domani alla funzione domenicale ma, nonostante tutte le raccomandazioni, si è ripresentata a casa dopo scuola nel tardissimo pomeriggio – con il cane che pretendeva di entrarle appresso pure lui – con un nuovo ed enorme squarcio nella gonna. Chissà come se li procura. Al solito, però, aveva cominciato ad accampare scuse. E’ capace di farmi girare la testa con tutte le chiacchiere che è in grado di snocciolare, le storie più strampalate ed astruse – è sempre colpa degli altri: “E’ stato questo, è stato quello” – per tentare di giustificarsi e farsi passare per una ragazzina a modo, tutta buone maniere e compostezza. Le ho dovuto chiudere il becco con una sberla. Lo sanno tutti che è sempre lei la prima ad inventarsi i giochi più spericolati, per mettersi in mostra davanti agli altri. Ha solo otto anni ma la testa più dura di un caprone, come il padre.
E così ho dovuto rimettermi a lavorare su questa gonna turchese sbiadita dal tempo e dai lavaggi, invece di potermi dedicare ai vestiti delle poche clienti che ancora si ricordano – ogni tanto – di pagare la sarta, anche se a rate o con lavori in contraccambio, verdure, carne, uova.
Ma lo schiocco di un vetro spaccato mi ha fatto sobbalzare di nuovo sulla vecchia poltrona. Ho sollevato lo sguardo dalla stoffa lisa che tenevo tra le mani e l’ho levato al soffitto, mentre serravo la mascella per non esplodere.
Dopo un momento di silenzio ed il soffio di passi leggeri sulle scale, Christine appare con gli occhi grandi e scuri spalancati dal timore reverenziale. Tra le mani, i resti di un bicchiere da buttare.
Ha tredici anni, è già diventata signorina – certe volte mi accorgo che prova di nascosto le mie calze – e continua a comportarsi come una bambina con costante bisogno di rassicurazione. Mi dà più ai nervi lei, certe volte, che Myrna.
“Mamma, è stato…” ha provato a dire.
“Mamma è stato un corno!”, l’ho fulminata tirandole una ciabatta: “Torna subito giù e rimettiti a fare le faccende come ti ho insegnato. Usa un po’ di delicatezza, possibile che ti debba ripetere sempre le stesse cose? E appena quell’altra stupida di tua sorella ha finito di lavarsi i denti, fatti aiutare ad asciugare i piatti. Via!”
Christine è rimasta immobile. Pareva una statua, non fosse per le lagrime che le rigavano, dagli occhi, le guance. Poi ha preso a singultare, deglutiva a lungo – adesso sì che mi stava proprio per far arrabbiare – sembrava quella volta che, un anno o due fa, venne a piangere disperata perché Myrna le aveva detto: “Ma tu lo sai perché mamma non ti vuole bene come a noi? Perché tu sei stata adottata, non sei nostra sorella vera, me lo hanno detto a scuola: a te mamma e papà ti hanno trovato sotto i portici dopo che il circo era partito”.
“Via”, le ho strillato di nuovo: “Non ti voglio più vedere e sentire. E quando torno giù, voglio trovare tutto in ordine”.
Finalmente ha obbedito. Il rumore che era cessato in sua assenza è ripreso più attutito – anche se interrotto da qualche singulto – ed ho potuto ricominciare a spingere sui pedali della macchina per cucire ex elettronica che il figlio di Foost ci aveva regalato, riadattata, al matrimonio.
Ecco come passo le mie giornate da quando quel figlio di puttana se ne è andato, lasciandomi sola – altro che Christine – con tre figlie femmine da campare.
Brainwell
Non è certo come trovare un dromedario conservato nella sabbia, ma ringraziai tutti i Soli e le Lune la mattina che inciampai nella carcassa di un piccolo maiale selvatico.
M’ero allontanato un bel po’ dalle case popolari e avevo il cervello distratto dai filari di pali della luce – che scendono dalle fattorie di steli – distribuiti in una sequenza che poteva essere letta attraverso gli appunti sulle logiche ritmiche prima della Gloriosa Ricerca, scritti da mia madre decine di anni fa.
L’esemplare della bestia era grosso appena poco più di un capretto nano, ma abbastanza comunque da ricavarne pelle per uno djembe di medie dimensioni. Era coperto di bozzi su tutto il corpo, ma senza lacerazioni. Solo la testa – sfigurata dalle mosche – era a un paio di metri di distanza, tranciata di netto chissà da chi. Il fetore della carne putrefatta aveva già ammorbato l’aria e dovetti filtrarla calando la mia kefiah sul naso.
Pregai verso il Primo Sole – benedicendo il sacro pneuma dell’animale che mi si donava, così come il mio vegetarianesimo imponeva – e con il serramanico lo scuoiai sul posto. Con la pelle infilata nella sacca tornai subito a casa.
Un nuovo tamburo era necessario. Nei primi giorni di Circo qualcuno mi aveva scippato il bendir ereditato da mamma e avevo dovuto arrangiarmi con il solo cassone da 18 pollici che sembrava attrarre esclusivamente gli storditi dai fiori. Quei giovani con il naso impiastricciato dal nettare è gente che non paga. Le famiglie invece – minacciate dai pianti dei piccoli – stanno intorno ad ascoltare le nenie degli avi ed i ritmi antichi della Colonia. E qualche centesimo finisce nel cappello.
Ma il Circo ripartì subito ed anche quel mese feci pochi incassi. Non è che si possa tirare avanti a lungo con qualche matrimonio o festa di quartiere, e certe volte incorre la dolorosa necessità che debba anch’io ridurmi ad andare a lavorare. La speranza immortale e condivisa da larga parte della popolazione è di abbandonare questo posto dimenticato anche dal Dio dei Buchi Neri. Pregavo ogni sera affinché il mio nome cominciasse a circolare per tutto l’Alto Universo – richiesto per sagre planetarie, concerti e speciali televisivi – e così l’intera Colonia, nei giorni delle Sacre Congiunzioni, avrebbe visto le mie interviste e ballato al ritmo delle mie percussioni in tv.
Solo mia madre non avrebbe gioito. Una vita – la sua – passata a intervistare i vecchi ed ascoltarne i canti, approfondire i significati, studiare le produzioni musicali di prima delle guerre civili, indagare sulle sequenze numeriche secondo cui era stata progettata la Colonia e alle quali affiancava i pattern ritmici tramandati dalla tradizione. Non aveva mai ricercato la celebrità perché non le era mai davvero interessata, o forse perché la Gloriosa Ricerca e l’ideologia del Gran Partito non avevano mai gradito celebrità poco manovrabili. Mia madre fece parlare di sé solo quando scomparve, inghiottita non dalla fama di una tournée galattica bensì dall’ossessiva follia che tutto avesse origine da determinate sequenze ritmiche, una cosa – evidentemente – che non sta né in Cielo e né in Terra e che mai e poi mai prenderà anche me. E se quella volta del maiale, in quei semplici pali di dimensioni diverse che degradavano dai campi di steli, io riuscii a leggere gli accenti forti, i battere, i levare, la durata – una serie di sequenze riconducibili ai sette movimenti che secondo gli appunti di mia madre costituivano la clave in sette che strutturava tutta la tradizione musicale ai tempi prima del Balzo in Avanti – non c’è niente di male perché è un dato di fatto. Lo capisce pure un bambino.
Lo strano è che l’ansia mi colse – per la prima volta – proprio mentre la pelle di maiale essiccava al sole e nella testa aveva preso a martellarmi un ritmo in sette quarti.
Ursula
Cavolo: le sei.
“Corinne alzati, sveglia, prendi i tuoi fratelli e lavali. Fra mezz’ora pronti per la colazione”.
Ecco l’angioletto di casa: “Devi fare i bisogni, piccola?” e Lassie scatta scodinzolando verso la porta. Gliela apro, la oltrepassa ed è sulla veranda.
Si sente solo il rumore delle zampe sul legno e quello del vento che – giù dalle scale – spinge e rincorre i mulinelli di polvere attorno alla stele di ardesia dove riposano i miei. Non c’è un albero una pianta un cespuglio. Solo terra e sassi a perdita d’occhio e poi le dune e il mare – forse – che non si vedono ma che pure, a volte, sento.
Tutti preferiscono le zone coltivate di là dalla Colonia, prima che comincino i boschi e le foreste: “Ci sono più colori”, dicono, “e rumori ed odori d’animali e di insetti”.
Quando ero piccola rimanevo ore seduta qui sugli scalini, da sola. Mia madre in piedi – dietro le mie spalle – diceva: “Ehi sentinella, novità all’orizzonte?”
Mi voltavo a guardarla, per tornare subito a riperdermi nella vista del deserto. Credevo che se qualcuno o qualcosa dovesse mai apparire in colonia, era da lì che sarebbe passata. Ancora adesso ho questa sensazione e continuo ad aspettare, da brava sentinella.
I rumori dalla cucina mi scuotono. Lassie fa l’ispezione mattutina attorno allo steccato. Qualche grillo-topo deve aver scavato nel suo territorio. Infila il naso in fondo al buco e ringhia. Non le è bastato il morso sul muso dell’altro giorno.
Di là dai vetri vedo Corinne apparecchiare, mentre Tom e Leon si rincorrono ridendo. Il padre non c’è. Lui dorme benedetto uomo, e a me è già finita la mezz’ora d’aria.
Entro in cucina ed i ragazzi interrompono preoccupati i giochi. Sorrido. E si precipitano ad abbracciarmi le gambe. Gli carezzo i capelli e li faccio sedere.
Corinne mi fissa. Lo fa sempre. Pare mi studi. Passerà. Ha quindici anni. Anche a me non piaceva mia madre, ma mia madre era la cosa più dura che avesse mai attraversato questa terra. Io a lei non la costringo a venire in palestra con me o a correre per ore nel deserto. “Ursula”, diceva la gente quando ci vedeva allenarci e combattere: “Tua madre è pietra lavica, antica”. Lei viene solo quando le pare.
I piccoli hanno ripreso a farsi dispetti. Corinne li sgrida e loro guardano me, fingendo di ignorarla. “C’era corrente stamattina o siamo ancora razionati?”, le chiedo.
“Andava e veniva”.
La cucina è in perfetto ordine. E’ in gamba Corinne. Riesce a mantenere tutto funzionante. Dopo il liceo vuole studiare biomeccanica: “Non voglio fare il tuo lavoro”, dice.
“Fa’ quello che ti pare”. Intanto m’accorgo che ha rimesso a posto il vecchio scaldavivande: “Come hai fatto?”
“Niente…”, alza le spalle e sorride.
“Brava”, le sorrido anche io. “Vado in ufficio”, comunico poi, “non fate tardi a scuola. Via!, andiamo” faccio segno a Lassie, mentre già le apro lo sportello.
La macchina parte al primo colpo. Menomale. Se mi fa un’altra volta qualche scherzo, me lo mangio vivo il vecchio Foost.
Arrivo in piazza, costeggio il colonnato dove – al solo scorgermi – due giovanotti della guardia colonica in ritardo si sbrigano a nascondersi. Parcheggio davanti all’ufficio: andrebbe ripulito, a cominciare dai vetri che fanno pena.
Dentro c’è Rooney – l’ultimo arrivato – alla fine del suo turno di notte. Lo ha voluto il Giudice. Io non lo volevo: “Questo è uno che ce lo mette lui il naso dentro i fiori! Ma perché la Federazione non li ha sterminati tutti cinque secoli fa, quei cavolo di fiori, come fece con il tabacco?”. “Falla finita”, aveva detto lui: “Abile e arruolato”.
“Leva quei piedi dal tavolo”, gli intimo però dalla porta, “mica stai a casa tua”.
“Buongiorno sceriffo!” scatta Rooney sull’attenti, facendo cadere la sedia per terra mentre Lassie – cretina – gli salta pure addosso a fargli le feste. Giuro che la ammazzo.