Cronache da un pianeta abbandonato - II capitolo - Il pozzo
Categoria: ...Altro, Cronache da un pianeta abbandonato, Progetti
Postato da: zaphod
Karel
La prima pioggia d’autunno. Ieri il cielo era terso. Stanotte invece s’è levato il vento addensando le nubi ed oggi è piovuto a violenti scrosci e fragori di tuono. Poi il vento s’è placato ma – prima – ha risgomberato il cielo, che a sera era di nuovo terso.
“Un temporale estivo?” chiede speranzoso mio figlio, mentre dopo cena lo porto a prendere il gelato in piazza. Non lo vorrei disilludere, ma l’estate è finita e il manto verdechiaro che sotto i platani già marcisce nella belletta parla da solo: “Cadono le foglie” gli dico per non mentire, stringendogli un po’ più la mano lungo il viale sterrato delle case popolari. L’asfalto s’è corroso da sempre ed anche la ghiaia emerge appena, dalla sabbia che arriva dal deserto.
Sull’incrocio con la circonvallazione cigola penzolando il semaforo dal cavo. Mio figlio non alza neanche più la testa. Anch’io non l’ho mai visto acceso.
Lui si rianima in prossimità della piazza: “Dov’era il varco, papà?” mi richiede.
Mi chino, indicandogli col dito dritto davanti al viso la fontana con la palla: “Guarda dalla cima della palla allo spigolo dell’Intendenza: in quella direzione, oltre le lune, mio padre diceva che da piccolo vedeva il Varco folgorare, quando lo attraversavano le astronavi” e fingo di ridere. Un Varco Dimensionale non è da noi che una favola per bambini. Neanche ci crederebbero se non ci combattessero ogni tanto – se c’è energia – alla playstation di pastore Jacob. Colonization si chiama il videogioco, e bisogna costruirsi un Impero conquistando il predominio sugli altri concorrenti. Fondamentale è, nella strategia del gioco, il controllo e l’accesso alle vie di comunicazione. Bisogna costruirsi una rete di Varchi che – forando come pozzi il continuum spaziotemporale – consentano di spostare all’istante eserciti, risorse e merci su e giù per l’universo conosciuto. Se si entra nel Varco Dimensionale di Bethelgeuse-5 per esempio, il sistema di connessione ti infila nel wormhole spazio-tempo e, in meno di un nanosecondo, sbuchi come un proiettile dal Varco che avevi selezionato nella parte opposta della galassia. Il tempo di viaggio sta tutto nelle sette od otto ore necessarie ad entrare in orbita sul tuo pianeta, raggiungere la velocità della luce ed infilarti nel Varco. Poi, da lì, altrettante per la decelerazione e lo sbarco.
Bisogna però è costruirla passo passo questa rete intradimensionale – un Varco alla volta, e solo un certo numero di giga-luce un po’ più avanti dell’altro, non di più – perché sennò si impicciano i calcoli e se si sbaglia solo un milionesimo di decimale, il wormhole ti sbatte in chissà quale era di una nana rossa in ebollizione. Solo alla fine – quando c’è tutta la rete – si può saltare all’istante di qua e di là della Galassia. Però ogni Varco costa e non solo d’impianto e messa in orbita dei piloni d’energia, ma soprattutto d’alimentazione: energia pura senza interruzione. L’unica è calcolare il rapporto costi-benefici e – se un Varco finisce per servire un’area a scarso traffico – tagliare il ramo secco ed investire altrove. Noi diventammo secchi subito, appena annullato il Balzo in Avanti: “Chi vuole tornare indietro torni”, ci dissero, “chi invece vuol restare, peggio per lui”.
Restammo la metà. I nostri nonni.
“Sicuri?” rifece la Federazione.
“Hic manebimus optime” disse il primo Giudice. Quelli sparsero le loro bombole di spore defolianti antitabacco e smontarono il varco – “Adieu” – portandoselo via. Ora occorrono, per il più vicino, quattro mesi di navigazione e altrettanti per tornare. Chi vuoi che venga più? Giusto i circhi, appunto.
Ma mio figlio ha finito il gelato. Torniamo indietro. All’angolo della piazza – Spes ultima dea – mi volto a riguardare il cielo. Triste però è l’autunno anche per me. Nessuna luce, nessun circo in arrivo.
L’ultima odorava di rose.
Erika
Noi stavamo giocando in cerchio a bottiglia in mezzo allo stradone. Allys in calzoni corti invece stava sugli scalini dell’emporio con la testa tra le mani. Neanche ci guardava. Ma neanche a scuola mi guardava e quando mia madre mi mandava a comprare le bustine per l’acqua effervescente e lo salutavo, mai una risposta, mai un cenno, e anche quel giorno guardava fisso e torvo sulle scale la punta delle sue scarpe, mentre nella strada la bottiglia girava girava.
Lentamente si fermò dinanzi a Yurij dagli occhi azzurri, che poi morì colpito dal fulmine quella notte che dopo il liceo – al nostro primo turno di servizio nella guardia – tracimarono i valloni e ci inviarono in soccorso ai campi di steli. La folgore lo ghermì sull’argine e Yurij precipitò nel vallone. Ne ritrovammo il corpo solo il giorno dopo, dove i fiumi scompaiono nel deserto. Ma quella volta – insieme alla bottiglia – s’era fermato anche il mio cuore, a pregare tutti i Soli che Yurij scegliesse me. Seguii i suoi occhi azzurri ed i capelli neri – anche Ursula lo voleva – e ripresi a vivere solo dopo che l’ebbe oltrepassata. Si abbassò mentre radiosa gli alzavo il viso a ricevere il bacio. Ma d’improvviso mi trovai a terra – nella polvere – tramortita da una botta sulla testa e subito Yurij m’uscì dai pensieri: “Allys! mi vuole bene” scoprii, non vedendolo più sugli scalini ma, coi pugni stretti, puntare adesso verso il piccolo Yurij indietreggiante.
Fermai Ursula che in posizione di kama-te già fronteggiava Allys e lo sfidava: “Mettiti con me, se hai coraggio.”
“Fatti gli affari tuoi” le dissi, e me lo presi per mano. Il vento sapeva di mare. Ecco come mi sono innamorata.
Non parla mai. Parlo io. E per farmi stare zitta, ogni tanto mi ridà un pugno sulla testa. Ricominciò dopo sposati – eravamo nella cameretta di sopra, era ancora viva sua madre – una sera che faceva freddo e per non riscendere di sotto accesi la stufa con un librettaccio tutto consumato di un filosofaccio antico su cui aveva dato la tesi: “Illiceità del progresso e apologia della decrescita nella gnoseologia reazionario-esoterica delle comunità arcaico-primitive”. Lo conosceva a memoria, a che gli serviva più? “M’hai bruciato de Benoist!” strillava invece, e mi ridiede un pugno sulla testa.
Non so che mi prese. Lo abbracciai spingendolo sul letto. Aveva fino allora sempre fatto tutto lui, senza dire una parola, e io rigida: “Fai con comodo” pensavo ogni volta. Ma quella sera lo sbranai come una tigre, anche se dopo pochi colpi il fuoco subito mi si spense: “Che faccio, io, a cavallo qua?”. Non m’andava più e feci per scendere. Prima mi tenne le gambe e poi “Tum!”, un altro cazzotto in fronte. E mi riaccesi.
Adesso sta con un piccone in spalla – dopo vent’anni che non s’è mai mosso – pronto per uscire con quel disgraziato di Martin. Sophie si perde il marito e chi ci va di mezzo sono io. Quell’impicciona di Ursula lo aveva convocato per gli alimenti e l’abbandono del tetto coniugale e lui, sulla scrivania, aveva visto le sue pietre: “Dove le hai trovate?”.
“Sono io che faccio le domande, Martin”.
“Sì vabbe’, ma dov’è che le hai trovate?”.
“Nel deserto, lungo il secondo pendio della cresta di Woomeang”. Sta disgraziata.
Le ha firmato di corsa il verbale senza leggerlo – “Vabbe’, mi fido” – s’è preso i sassi e è ripiombato qui: “Il filone! Ho trovato il filone”.
Allys pareva Lazzaro e – morto e sepolto da sempre: “Iam fetet” – appena ha sentito “filone” ha capito “Risorgi!”
Sono tre giorni ormai che fanno avanti e indietro a trasportare roba nel deserto. E io a mandare avanti la baracca.
L’ho chiamato nel retro. “Ma che filone e filone? Non eri per la decrescita tu?” gli ho ringhiato. Mica ha risposto. M’ha dato un cazzotto in testa e se n’è andato. Così mi si è acceso il fuoco. Speriamo almeno che duri fino a sera.
Foost
Ottobre caldissimo. Pare quasi ancora estate. In officina tutti armeggiano sudando tra forge e lamiere. Piglio una pasticca di Stavras e sguscio in casa.
Quella però – come mi vede – s’alza dal rimestare il fuoco nella stufa e urla: “Non ne posso più!”, buttando i tegami all’aria e asciugandosi un rivolo sul collo: “Io sono vecchia! Posso continuare a cucinare per tutti voi con questo caldo e addosso al fuoco? Non hai nessuna pietà di me?”
Ma sei tu che non ce l’hai di me – le vorrei dire – mica è colpa mia se qui l’unica fonte d’energia è la legna. E io allora, che con tutto quello che ho da fare mi tocca pure andarti a tagliare gli alberi oltre Monthell Hill, farteli a tocchetti e poi portarteli uno ad uno fin sotto quella cavolo di stufa? Ma ti ci ficco a te dentro la stufa, prima o poi.
“Inventati qualcosa!”, fa.
Ma che vuoi che m’invento? Ma non lo sai pure tu che per produrre energia ci vuole altra energia? Per la legna la fatica mia e per i campi di luce i metalli da plasmare. Nulla si crea nell’universo umano e tutto invece inesorabilmente – mannaggia a te – deperisce e muore. L’energia che si produce non compenserà mai quella che s’è sprecato per produrla. Sennò avevamo trovato il moto perpetuo, no?
“Va bene, va’,” le ho detto: “Mo’ arrivo su Vega e ti compro una bombola di gas, ti si schiantasse addosso il Primo Sole”. E sono tornato a lavorare.
Non faccio però in tempo a scendere che – dalle scale – vedo il macinino dello sceriffo che arranca verso il cancello. Giornata storta. Urlo: “Corinne! nasconditi che c’è tua madre”. La pulce molla l’oliatore sul tornio e s’arrampica come un gatto nel sottotetto. Spengo il tornio e vado incontro a Ursula: “Comandi, sceriffo: come vede, qui non c’è lavoro minorile”.
Lei si guarda intorno, poi – facendo finta di niente – mi chiede di Martin e di Allys: “Ma che stanno cercando?”
“E che ne so?”, faccio io.
“E i macchinari di scavo chi glieli ha dati?”
“E chi vuole che glieli abbia dati? Mi pagano l’affitto. Mica è reato, no?”
“No”, fa lei. Ma non se ne va. Non è convinta.
Io mi metto a sistemare gli incastri e le cerniere a cui stava lavorando la figlia. Ha piglio. Ha genio. Se lo viene a sapere lei ci ammazza, ma con quei pioli è stata un fenomeno: è bastato che le dicessi che mi sembravano storti, e subito ha capito che andava calcolata una conicità più ampia, prima di iniziare ad asportare il materiale in eccesso uscito dallo stampaggio. Ha visto il pezzo già finito – proprio come una statua e lo scultore – nel blocco grezzo dell’ottone. Ragiona in sincrono con il cervello delle macchine. Ma se non si comincia da piccoli, quando si impara a farsi metalli coi metalli? Dopo non c’è corso di recupero, anche se per loro è “reato federale”. Ne debbo parlare al Giudice.
Con quella sempre alle calcagna mi metto quindi a combattere con il derrick, le cinghie e la caldaia che ho riadattato per l’argano da dare a Zacharias. Dovrebbe passare stasera a prenderlo. Lui dice che poi paga, ma intanto sono mesi che ne parla: io lavoro, consumo gli attrezzi e ancora non si vede l’inizio né del pozzo né dei pagamenti.
“Pure Angie però”, prova a tastare Ursula finto-confidenzialmente, “che bisogno aveva di mettersi a scavare un altro pozzo?”
“Senta sceriffo, ma che è reato pure scavare i pozzi? Ma lei oggi non ha proprio nessun altro criminale da andare a perseguitare in tutta la colonia?”
“Ho capito va’, non le sto simpatica”. Se ne è andata, e subito la figlia è riplanata dalla capriata. Io però ho continuato a guardarla – già al di là del portone – con la pistola che nel passo le sbatteva sulle reni e la coda di cavallo, bionda, ondeggiante al vento. Lo sceriffo peggiore della galassia, ma anche il più bello. Mentre a me rimane sullo stomaco – mannaggia il caldo – la pillola di Stavrakopoulos sprecata.
Brown
“Fuma…”, aveva bisbigliato Myrna.
“Fuuuma?!” avevamo ridetto noi, facendo appena in tempo a scorgere dal cespuglio – lontana – la testa del Perfido Blackman avvolta in una nuvola bianca.
“Fuma!” aveva ristrillato lei, “e caccia pure fuoco e fiamme”, e via di corsa.
“E’ il Diavolo” e via di corsa anche noi. Lei già rideva di nuovo. Era la seconda la volta che ci andavamo. Poi per mesi più niente. Io la notte sognavo quella testa che lanciava fuoco e fiamme. Strillavo nel sonno. Mia madre veniva a baciarmi: “E’ un incubo, ora passa”, e mi riaddormentavo felice tra le sue braccia.
Haccious dice che Perfido Blackman è stato bandito dalla Colonia. Chiunque entri nel suo capanno, lui perciò lo fa a pezzi e poi lo mangia. Il sangue lo beve e conserva i teschi in un armadio. Myrna non gli crede: “Sei un pallonaro” dice, però lo guarda interessata. Alla fine è toccato riandarci. Io non volevo. “Andiamo noi due”, hanno detto. E sono ripartito anch’io – tutta l’estate – in mezzo a quelle strane piante, a spiare Blackman che tagliava foglie e le stendeva ad essiccare sui pali al Primo Sole. Ho la sensazione che qualche volta si sia accorto di noi, voltandosi all’improvviso dalla parte nostra ma facendo finta di niente. Noi subito scappavamo.
Ora tutta la colonia va a vedere i lavori del pozzo di Angie, o quelli del padre di Myrna e del suo amico scemo che scavano nel deserto. Noi lì ci siamo andati una volta sola, ieri: “E che ci sarebbe da vedere qua?”, ha detto Haccious schifato a dei ragazzi storditi dai fiori. E siamo tornati dal Perfido Blackman a fare a gara a chi rubava più foglie.
Stavamo nel mezzo del campo – acquattati – quando però è uscito dal capanno. S’è seduto spalle alla lamiera. Ha deposto pizzichi di quelle foglie marroni su uno strisciolino di carta. Lo ha avvolto, leccato il bordo e richiuso a cilindro. Lo ha messo in bocca e con uno zolfanello lo ha acceso. Yu dice – al doposcuola – che non c’era niente che uccidesse come il fumo. Bastava che fumavi e poi morivi. Blackman invece fuma e campa. E ha un’espressione pure felice, mentre il fumo gli esce dalla bocca e dalle narici.
All’improvviso ci vede. Noi impietriti. Butta quel cilindro, fa un salto ed è su Myrna. Io vorrei scappare. Laika scappa davvero. Ma Haccious s’alza e s’avvicina a Myrna. M’avvicino pure io. Laika si sente già guaire in fondo ai canaloni.
Perfido Blackman ride. Io tremo di paura. Mette una mano sulla spalla di Myrna e – spingendola – ci guida al capanno. Noi dietro. “Stasera finisco in quell’armadio” penso. Invece si risiede, arrotola un nuovo cilindro – “Si chiama sigaretta”, dice – e lo accende scrutandoci. Noi zitti. Dopo un paio di boccate, sorride invitante e allunga l’enorme suo braccio, porgendo la sigaretta a Myrna che ora non ride più.
E’ Haccious però che si rifà avanti – anche se si vede che ha paura – la prende lui e la porta alla bocca. Un primo timido tiro. Poi uno più convinto. Esala la sua nuvola e guarda noi due con trionfo – “Che ci vuole?” – ma subito un accesso di tosse lo fa piegare in due.
Blackman sghignazza.
Myrna lo guarda allora negli occhi, raccoglie la sigaretta caduta a Haccious e fa un tiro piccolo, con una piccola nube di fumo. Delle lacrime le si formano agli angoli degli occhi. Ma riesce a controllarsi e fa un’altra piccola tirata. Poi me la porge. Esito. “Tocca a te” insiste. Non mi posso rifiutare.
Aspiro il fumo che mi brucia la bocca. Lo ributto fuori. Tremo e serro i pugni. Ho superato la prova. Ma mentre ridò la sigaretta a Myrna le contrazioni m’assalgono all’improvviso, dall’interno del corpo, insieme a tutto quello che ho mangiato a pranzo. Glielo verso sulle scarpe. Lei urla schifata. Blackman ride. Haccious tossisce ancora. Mi sento male. Avrei voglia di morire. Ragioni ne avrei tante.
Yu
Colti gli ultimi pomodori rimasti, ho eradicato le piante e iniziato a vangare. Le galline mi ruspavano tra i piedi. Se tutto va bene, domani finisco e – di fianco ai broccoli – metto tutte patate. Lo sceriffo dice che i regolamenti d’igiene vietano l’allevamento di animali da cortile in città. Ma ce lo hanno tutti sotto casa, o nelle vicinanze, un orto ed un pollaio. Come faremmo altrimenti? L’unico – ma è anche l’unico che non va mai a tagliarsi la legna da solo a Monthel Hill – è il Giudice: “Che vuole da me”, ha detto un giorno: “se tutti mi vogliono bene e mi portano omaggi? Si faccia voler bene anche lei, oppure si procuri del ruscoroid”.
Chiudo il pollaio e – prima di rientrare – poggio le uova sul davanzale del finestrone e mi lavo alla tinozza lì sotto. L’acqua è poca – quella del serbatoio – e mi tocca pomparla a mano. Dentro già m’aspettano gli universitari del nuovo corso.
Dove c’è la biblioteca adesso, prima c’era l’albergo Colonia. La sala grande di consultazione adulti a piano terra – quella che sul retro chiude ad emiciclo, coi pilastri e la serie ripetuta di finestroni verticali che danno direttamente sul pollaio e sul mio orto – era il ristorante, il salone delle feste. Il sabato sgomberavano i tavoli addossandoli ai muri per liberare una rotonda al centro. Dove sto io in alto con la cattedra quando faccio il doposcuola ai bambini, suonavano gli orchestrali mentre lì volteggiavano le dame ingioiellate. Ogni tanto un ufficiale della Flotta ne scortava qualcuna al chiaro delle lune – tra scrosci di fontane, vialetti di ghiaia e cespi di rose – proprio dove domani pianterò le patate.
Sulla facciata principale – quella che dà sulla piazza – sopra le finestre del secondo piano c’è ancora la scritta nera sull’intonaco rosso “Grand Hotel Colonia” e sotto, protetti dai portici, gli ingressi davano sui bar e le sale da biliardo. Ai piani superiori, le camere in cui si alternavano – ogni quindici giorni – i gerarchi in visita del passato regime e le migliori cocottes della galassia. Oggi solo i miei universitari.
O meglio, all’ultimo piano – a parte la mie due camerette – i materiali d’archivio. Al piano di mezzo loro, che sporchi di terra e ancora odoranti di stallatico studiano da astronauti o ingegneri subatomici, pur sapendo che – nell’arco della vita – non gli potrà capitare nient’altro di più complesso che guidare un carro da otto buoi, avanti e indietro, da Villanueva do Carço a Šabőtzniegorod. Ma questo è il nostro sistema scolastico: “Non si transige!”, ripete sempre il Giudice al Consiglio, “non possiamo regredire e farci trovare impreparati, il giorno che magari arrivano davvero i Tartari”.
“I Tartari?”, chiesi io una volta.
“Guarda che professore, va’”, fece lui sprezzante.
Così dopo le scuole a palazzo K – elementari, medie e liceo, coi docenti che spiegano ed interrogano – passano qui, appena iniziato il servizio nella guardia. Io non spiego od insegno nozioni, poiché nessuno – nemmeno il Giudice, se pure vuole – può conoscerle tutte a questo mondo. Io insegno loro come si impara, gli insegno a saper studiare da soli sui files immagazzinati nella Sfera ed aggiornati – alla Congiunzione – d’anno in anno. Non possiamo mandarli all’università su Vega? E io controllo e sovrintendo che superino abbondantemente – con eccellenza – tutti gli standard previsti pure su Vega. Continueranno a mungere le vacche? Ma con la laurea in fisica o meccatronica.
Sempre più spesso però mi chiedo a che serva. Per il tartaro, dovrebbe bastare il dentifrico. Ma è il mio mestiere. Anche se per fortuna, ad ogni nuovo corso, ne trovo qualcuno gentile che – il sabato – m’ammazza e pulisce un pollo. Io non ne ho il coraggio.
“Lei, da solo, morirebbe di fame” disse una volta il Giudice, strozzandomelo lui il pollo.
Angie
E’ già un mese che scava. Alla fine ha vinto lui. “La Goccia”, lo chiamava sua madre. “Quando Zacharias vuole qualcosa”, mi ripeteva come se non lo sapessi, “è una goccia che scava le pietre”. E’ stato così anche con me. All’inizio non lo volevo, mi piaceva Yurij dagli occhi azzurri – a tutte piaceva Yurij – ma a forza di vedermelo girare intorno, ho iniziato a guardarlo pure io. Mi dicevo che non era adatto a me, ma ovunque girassi lo sguardo c’era sempre solo lui. Voltavo l’angolo della piazza e lo trovavo. Mi mandavano a ritirare la farina al mulino di Borsât a Villanueva do Carço, e lo trovavo anche lì. Mi leggeva nel pensiero. Mi anticipava. E me ne sono innamorata. Non è d’altronde che ci fosse tanta scelta in Colonia.
Zacharias si fissa. Normalmente lavora e basta – più in officina o dai vicini però, che nei nostri campi – ma quando si fissa ridiventa la Goccia. Che bisogno c’era di un altro pozzo? “Per i campi di luce”, ha insistito per mesi.
“Ah, certo” facevo io: “Per i campi di luce, per le vacche e per le altre colture. Ma chi lo scava questo pozzo?”. Lo so anch’io che l’acqua non è mai abbastanza. Ma anche le forze non lo sono: “Non stiamo bene così?”, gli dicevo. “Non ti basta la tranquilla serenità in cui viviamo? Perché queste smanie, perché cercarsi i guai?” e pensavo anche alle serate in palestra, che rischiava di farmi saltare.
“Tu sei contro il progresso”, ha grugnito per mesi. Alla fine ho ceduto.
“Faccio tutto io”, diceva, “prendo un lavorante, prendo le attrezzature da Foost”. E invece è toccato fare tutto a me e pure da Foost – che ci avevo litigato l’anno scorso per gli aratri: “Mai più!” gli avevo detto – ho dovuto riandarci io. S’era fatto rifilare un argano a vapore. Chissà dove lo aveva scovato. “E chi la taglia la legna per il carbone?” ci ho rilitigato, e me ne sono fatta dare uno misto: quando avanza energia dagli steli va con quella, e sennò col mulo.
Per lavorante invece m’ha portato Brain. S’era detto Martin, ma adesso sta a scavare miniere per conto suo nel deserto. Tutti scemi i maschi in questa Colonia, e tra tutti m’ha portato Brain. Conoscevo la madre. Era venuta qui a suonare per le nozze d’oro dei miei. La chiamammo pure quando nacque Paul. Scema pure lei. Ma non come il figlio: “Piacere, Brainwell Nynny-Brontë musico” s’è presentato.
“E io sono Jane Eyre sfigata” volevo dirgli, ma mi ha stretto la mano portandosela poi sul cuore e quando gli ho offerto il caffè, già teneva lo sguardo fisso nel vuoto – “Andiamo bene” ho pensato – e mi sono accorta che contava i tic tac della pendola in fondo alla sala. Con le dita ne scandiva il tempo.
Coi carri dell’attrezzatura siamo scesi al campo esterno, dove s’era già deciso di scavare. Lo sciroccato però s’è inginocchiato verso il Primo Sole e – faccia a terra – ha mormorato qualche cosa. Poi s’è alzato, ha sollevato un braccio verso il sole e un altro verso l’orizzonte – come a prendere le misure – e ha intonato una nenia. Ha strappato da un eucalipto un ramoscello verde a V e tenendolo dritto avanti a sé, mentre i piccoli ridevano e Paul seguiva la nenia battendo il tempo con la mano sulla gamba – gli ho dato uno schiaffone – ha camminato per cinquecento metri fino sopra il pianoro degli steli. La forcella d’eucalipto ballava tutta adesso, e lui ieratico ha alzato le braccia: “Questo è il punto! da qui Madre Terra elargirà il suo nettare”.
“Sui miei steli? Questo è matto, mandalo via” ho urlato a Zacharias: “L’acqua si cerca in basso, non in alto”.
“Che ne sai tu?” e il pozzo lo ha fatto impiantare lì. Per farmi dispetto.
Ho detto allo scemo: “Puntualità e olio di gomito, però! E guai a te se ti vedo annusare un fiore o un tamburello in mano”. Poi a casa ho preso la spada e sono andata a sfogarmi nel fienile. Le vacche dalla stalla mi guardavano impaurite.
Jacob
Sono distrutto, ma grazie a Dio finalmente riassaporo l’aura protettiva della mia chiesa: “Iìììh” ordino ai muli ansimanti.
Non aspettavano altro. Si bloccano. Il carico traballa e un sacco – nell’inerzia – finisce per protendermisi fin sul collo. La mia voce possente si leva a chiamare quelli di casa.
Vedo di lato sgusciare dalla finestra di Anikem due o tre ragazzini. Corrono ridendo verso lo stradone e si infilano tra i rovi di palazzo K: “E’ il Perfido Haccious” commenta Ylenia sopraggiungente.
“Non si dicono queste cose! Perfido è solo il demonio”, e le misuro una frustatina di saluto: “Saranno venuti a tenergli compagnia”.
Natale è alle porte e sarà un buon Natale. Ero preoccupato prima di partire. Volevo portarmi anche Anikem, che pure tossicchiando m’aveva aiutato a riassettare il carro grande, ferrare i muli, ribattere le staffe verticali e stenderci sopra – ben tirato – il telo della copertura: “Ma perché padre”, chiedeva, “non prendete il calesse piccolo, più agile e veloce?”. Neanche rispondevo e sorridendo prefiguravo la sopresa – come fu per me, col mio di padre – della sua prima pastorale. Invece nella notte non chiuse occhio, col brontolio dell’asma e le urla dei polmoni che ci spezzavano il cuore: “Signore perché ci hai abbandonato? Non togliermi mio figlio”, piangevo tra le braccia di mia moglie.
La mattina ero partito solo, col carro e coi muli, per la novena di Natale. Loro vengono ogni domenica al servizio del mattino – i figli tornano anche il pomeriggio per la Galaxy-League – ma un buon pastore deve, almeno una volta l’anno, visitare lui casa per casa le pecorelle del suo gregge.
I muli, all’andata, più si allontanavano dal deserto e più – man mano che lasciate le case popolari ci inoltravamo nella verzura che fa ala allo stradone di Pyặvëlinskij – si ringalluzzivano. Alla rotonda, col carro vuoto, parevano cavalli da corsa. Poi a sinistra per Šabőtzniegorod. Sudest. Prima tappa.
I padri fondatori costruirono l’embrione della Colonia sul ciglio del deserto: a una cinquantina di chilometri a Nord dovrebbe esserci il mare e, con i traffici del Grande Balzo, la città si sarebbe dovuta estendere fin là. Invece è rimasta qui e a Sud – intorno a lei – c’è solo un arco di campi coltivati oltre il quale incombe, sullo sfondo di lontani monti, la foresta impenetrabile e il grande resto sconosciuto di un pianeta vergine e abbandonato. In questo raggio di venti chilometri uno stuolo di fattorie – il nostro sostentamento – e tre piccoli borghi per non dover venire tutti i giorni in città: un bar general-store, un luogo di culto e ambulatorio, la scuola per i più piccoli e il distaccamento della guardia. Stop. Lavorare notte e giorno, questa è la volontà di Dio: “In sudore vultus tui vesceris pane”.
“Eh, ma tu non sudi tanto” aveva però detto il rabbino di Šabőtzniegorod, guardando il carro che si riempiva e i muli che già annaspavano. Visito tutti, dormo nelle case dei maggiorenti parrocchiani, la sera tengo i sermoni nella stalle e vengono per cortesia o svago anche quelli delle altre confessioni – a Monthel Hill pure il lama e l’imam, solo don Fidel, a Villanueva do Carço, niente – e chi porta un sacco di grano, chi una forma di cacio, un salume, o l’olio per l’insalata e l’illuminazione. Col rabbino sono amico da ragazzo. Studiavamo assieme. A Šabőtzniegorod mangio da lui e alziamo un po’ il gomito, ricordando i bei tempi della guardia: “Se non venissi tu a estorcergliele sul posto”, dice, “e quando te le porterebbero loro le decime a casa?”
Ma ecco che arriva correndo il piccolo Anikem e – Dio ti ringrazio! – sembra in salute: “Vedi l’affetto dei suoi amici?”, dico a Ylenia.
“Eh, chissà che gli ha fatto il Perfido Haccious”.
“Ma allora sei perfida tu, calunniatrice d’una trapezista” e le sferro una frustata vera. I muli intanto rifiatano.
Dolly
Resto a guardare la cicatrice di Martin ancora alcuni secondi: linea chiara e definita. Il taglio ha permesso di arrivare in profondità, ricostruire gli organi e saldare le fratture. La sutura ha nascosto nuovamente ossa e muscoli. La ferita è rimarginata, resta un piccolo solco che pochi mesi spianeranno. Mi trattengo dallo sfiorarla, ma sento un fascino feroce per quel marchio sulla pelle di Martin.
Anche nella mia vita c’è un marchio. Una frattura. Ho amato mio marito. Amo i nostri due figli. Ma lui non lo amo più. Quando mi bacia, la sua barba anche rasata mi punge. Non mi piace l’odore che ha. Ieri ero arrivata a casa tardi, dopo due ore in palestra con le amiche. I bambini già dormivano: “Perfido Haccious!”, diceva Brown nel sonno. “Ma il Perfido non era Blackman?” mi chiedevo lavandomi nel mastello. Quando sono uscita, lui s’è messo a guardarmi fisso mentre m’asciugavo, e poi s’è alzato per lavarsi lui. “Oddìo”, e ho finto di dormire quand’è tornato. Ma ha insistito. Abbracci. Carezze. E la mia pelle è – purtroppo – ancora elettrica. Il suo viso invece più bianco, più stanco, le occhiaie profonde. Le labbra più rosse.
Riguardo la ferita di Martin e m’aggiusto un ricciolo. Una lacrima mi scende sul viso. Lui però si gira di scatto, forse ho singhiozzato senza accorgermene. M’asciugo e mi riprendo: “Il dottore vuole vederti per le radiazioni riabilitative. Domani sei già fuori”.
“Al lavoro?” fa lui.
“Al lavoro! E che ti credi che ci vuole?”.
Lo hanno portato qui due giorni fa. Pareva morto. Allys – il marito di Erika – non riusciva a parlare. A fatica siamo riusciti a capire che era crollata una galleria. Poco prima avevano fatto brillare una mina poi – appena diradata la nube della polvere – erano entrati con le traverse di legno. L’esplosione però aveva aperto una breccia – una caverna – in un materiale più friabile e un crollo di assestamento li ha travolti: Allys di striscio, perché era dietro, Martin in pieno. Se lo è disseppellito da solo, gli ha fatto il massaggio cardiaco e la respirazione bocca a bocca come imparato nella guardia, lo ha caricato su una carriola e portato fuori. Poi s’è messo alla sirena per chiamare aiuto, ma sono quattro chilometri e non arrivava nessuno. Allora ha attaccato i muli e con un carro lo ha trasportato fin qui dal deserto. Non so come – con quei sobbalzi – sia arrivato vivo. Stavrakopoulos lo ha operato d’urgenza. Gli avevo fatto un bidone di caffè. Intanto s’era adunata mezza Colonia. E’ arrivata anche Sophie – la moglie – con le figlie. E lui come ha ripreso conoscenza s’è messo a urlare: “Ci sono tonnellate di ferro laggiù! C’è il carbone!”
“L’antracite!”, faceva Allys, “c’è l’antracite!” e Sophie era tutta contenta. Ma poi è arrivata quella sgrinfia con gli occhi a mandorla di Šabőtzniegorod, e lui le ha sorriso e lei è corsa a baciarlo. Sophie s’è fatta rossa. Poi nera. Ha preso le figlie e se ne è andata.
E’ tornata oggi pomeriggio. Senza figlie. Vuole gli alimenti. Il Giudice ha sentenziato che le toccano pure per il cane: “Anche per Laika devi pagare. E se non ti sbrighi, ti leviamo la miniera”.
“Tu sei matta!” strillava lui: “La miniera è mia, l’ho trovata dopo la separazione, non è in comunione di beni” fin che non è arrivata la sgrinfietta – vent’anni – e Sophie se n’è riandata. Dopo un po’ ho mandato via anche la sgrinfia e – fatte le radiazioni – l’ho sedato. Ora dorme. Non c’è nessuno. E’ buio. Stavras è uscito e dovrebbe arrivare tra poco.
Mi rifaccio i riccioli allo specchio. Metto lo smalto lucente sulle unghie. Ritocco gli 80 gloss di rossetto. Indosso il vestito che m’ero fatta fare tale e quale al suo – lui è al cancello – e vado nella morgue. Mi tolgo le mutandine e mi stendo sul tavolo di marmo.
Entra. Mi cerca e non mi trova. Capisce dove sono e viene. Solleva la gonna e biblicamente mi copre.
Washington G.
Nick gira distrattamente il cucchiaino nella tazzina. Una goccia di caffè cade sul modulo. Sbuffo. Sorride: “Dormito niente, eh?”. Squilla il telefono. Infila le cuffie e risponde. Sono le otto e non può che essere – puntuale come il Primo Sole – la vecchia signora Al-Torquawi: “Mi passi mia nuora”. Vuole sapere come ha dormito il figlio.
Nick non ha neanche bisogno di guardare il multiplexer: A13-D29 è una delle combinazioni più usurate. Per questo capita che a volte non funzioni mentre la signora Al-Torquawi – in quegli istanti – diventa sempre più intrattabile. Nick continua a togliere e reinserire il jack, l’orecchio teso a sentire il click della connessione. “Serve aiuto?” gli chiedo. Scuote la testa, nervoso. Poi alza una mano come a dire “aspetta”, il contatto scatta, la comunicazione va a buon fine. Saluta la signora, posa le cuffie e tira un sospiro di sollievo: “Bisognerebbe decidersi a sostituire il contatto della nuora”.
“E che ci vuole? Basta che vada lei su Vega a prendere quello nuovo”, gli dico mentre arriva il turno montante: “Aspetta che si rompa del tutto piuttosto, e poi proviamo a rigenerarlo al microlaser”.
Usciamo. Il maglione mi si gela addosso. Muovo i piedi per riscaldarli, ma ho ancora l’acqua nelle scarpe. “Non si sente l’odore del mare!” aveva detto sorpresa ieri sera Tanija, appena messo fuori il naso dal tendone del circo: “Chissà che temporale farà stanotte”.
“Ma che stai a dire? Ma se non c’è un alito di vento, una nuvola in giro: tu sei matta” ero scoppiato a ridere.
“Nick Portier! chiamo te a testimone” aveva intimato allora lei all’infame: “Stanotte sì che saranno dolori, per voi”. E lui per ingraziarsela faceva le smorfie come aveva fatto il clown, fingendosi atterrito, e le si chinava davanti con le mani giunte: “Ti prego Semiramide, allontana da noi la sventura” e lei rideva. Io gli tiravo calci nel sedere. Poi l’avevamo accompagnata a casa, sbocconcellando per strada gli hot dog comprati fuori del circo, ed eravamo venuti in centrale per montare di turno: dieci ore ma senza ambasce – normalmente sarebbero otto, ma ne avevamo due da recuperare – solo stare di guardia in una nottata calma, pensavamo, e riposare.
Invece quando è stata mezzanotte è venuto giù il finimondo. La strega aveva indovinato. Un temporale appresso all’altro e colonne di luce che dal cielo sprofondavano nel deserto. Lampi in negativo – sul buio della notte scura – che si susseguivano l’uno all’altro. Non è una sventura per la Colonia, anzi: ogni fulmine che riesce a intercettare il Grande Obelisco piazzato sul ciglio del deserto al margine Ovest della Colonia, all’incrocio dell’Epitaphium, diventa una riserva d’energia che prima va negli accumulatori e poi man mano – quando serve – in rete. Immagazzina. Ma per noi è massacrante. Subito il capoturno – allarmato dai contatori che giravano impazziti – ci ha mandato in bicicletta sotto la pioggia torrenziale a disattivare un ponte elettrico a Little Rush, tre chilometri fuori città, per evitare che il surplus bruciasse tutta la rete. Per la Sfera di silicio non c’è pericolo, è costantemente disattivata nel caveau e le diamo corrente solo per interrogarla. Ma la tempesta sembrava non dovesse più finire. Cinque ore a arrampicarsi sui pali col telo incerato sulle spalle, o a scoperchiare tombini per tutta la città e scendere fin nelle più vecchie centraline telefoniche allagate.
Il cielo è terso, ora. Dei bambini vanno a scuola. Il maglione umido è sempre più freddo. Camminiamo verso la piazza. Ci dividiamo sotto il portico dell’Intendenza. Di là dal portico, quelli del circo rincorrono il tendone svolazzante nel deserto. Sono arrivati solo tre giorni fa e già ripartono. “Ma che sono venuti a fare?”, chiedo a Nick.
Neanche mi risponde.
“Quella sente il mare, Wash”. E se ne va.
Sophie
Come ogni volta che da palazzo K percorro al buio il viale che porta a casa – con solo il rumore del vento e l’oscurità della notte – mi tornano in mente certi vecchi film che vedevamo di nascosto in biblioteca da ragazze e, dal nulla, mi sento arrivare stormi di uccelli infuriati che si gettano con violenza su di me per sbranarmi. Da ogni cespuglio vedo spuntare un corvaccio nero col becco aguzzo, appostatosi lì solo per soddisfare le sue brame. E corro all’impazzata fino a quello che una volta era il mio dolce nido nuziale.
Anche Erika è una cornacchia che sparla sempre di tutti e mentre ci allenavamo al freddo della vecchia palestra di palazzo K ha detto di me: “Figurati se per avere la sentenza non s’è già fatta consolare pure lei dal Giudice”.
“Ma chiudi quella boccaccia” ha fatto Ursula.
Allora se l’è presa con lei: “Che c’è, sei gelosa?”
“Gelosa io? E di che?”
“Guarda che lo sanno tutti che tu gli fai i pompini”, e Ursula, come una furia, ha preso a tirarle a tutta forza – a fare male – i colpi di karate. Ma lei schivava, parava, saltava e continuava a cantilenarle: “Lo sceriffo fa i pompini al Giudice! Lo sceriffo fa i pompini al Giudice!”
Poi Ursula s’è placata: “Tu saresti capace di parlare male pure di padre Jacob”.
“Chi, quello?… E’ meglio che mi sto zitta, va’!” e allora anch’io ho fatto finta di ridere come le altre. Loro fanno presto: “Scherza Sophie, non te la prendere, curati di più, vieni in palestra”. Sembrano ragazzine; ma è per questo che ci sono andata, per stare assieme. Ma dopo due ore di arti marziali sono rotta, non sono più abituata. Tutto il giorno taglia e cuci fino a notte fonda, con l’unico intervallo del mattino in cui vado a casa del Giudice, che almeno paga, ma ogni volta è una montagna di panni da lavare a mano, i pavimenti per terra e tutto quel che sporca lui e il figlio. Lo so solo io la rabbia che ho.
Ma s’è fatto tardi e quel che resta del mio nido sembra una dimora di spettri. Laika – neanche un fiato – la scavalco sulla porta. Le sagome delle mie figlie – sui letti – paiono nel buio salme prive di vita, come me, che nel cuore pompo solo veleno. A quel figlio di puttana – non sia mai ricascasse la miniera in testa – mettono il telefono. Non c’erano più cavi in Colonia? Se li è fatti da solo: una trafila, un estrusore, una riunitrice e ha costituito la Fulgor Cables Mines Engineering.
“Lui si fa la Fulgorcables e a me non paga gli alimenti?” ho urlato al Giudice: “Che aspetta a sbatterlo dentro?”
“Non lo posso fare, porti pazienza”. Altro che consolare.
Le figlie però crescono e hanno bisogno di tutto. Myrna torna regolarmente coi vestiti sporchi di terra e macchiati di verde: “Me li puoi lavare subito, mammina?”. Io le mollo ceffoni: “Non la puoi smettere di sederti sull’erba?”. Ora puzzano anche di uno strano odore acido che non avevo mai sentito. Ha le dita gialle – l’ho portata da Stavrakopoulos ma sta bene: “Non ha niente” e intanto pago – si riempie le tasche di tutta l’immondizia che trova in giro: carta e foglie sbriciolate; perché me la deve portare a casa? Non ho già abbastanza da lavorare? Così metto le mani addosso non solo a lei ma anche alle altre: intanto perché se lo meritano e poi per il bisogno – mi serve proprio, ogni tanto – di colpire qualcosa o qualcuno. Forse farei bene ad andare più spesso a palazzo K. Ma non ne posso più dalla fatica.
Anche se è proprio lì – nella fatica – che trovo a sera un po’ di conforto al senso di vuoto che mi porto dentro tutto il giorno, e che solo nel primo dormiveglia si sfuma, mentre la rabbia e l’impotenza sembrano svanire.
Ma non è che un attimo e subito ripiombo per tutta la notte – mi consolasse davvero almeno il Giudice – in incubi infestati da stormi di uccelli neri che, dal nulla, si gettano con violenza su di me e mi sbranano a sangue.
Brainwell
“Thud, thud”. Prima la gettavamo noi l’acqua dentro il foro, per ammorbidire il terreno e aiutare l’asta di percussione – la sonda – a entrare. In meno di dieci giorni arrivammo a quaranta metri e l’acqua sgorgò a fiumi, pura come nettare. Ringraziai Tutti e Due i Soli e pensai: “Abbiamo finito”, riprendendo in mano il mio djembe. Zacharias disse: “No, è solo la prima falda e si esaurisce subito come l’altro pozzo: bisogna andare più giù”. La moglie ci guardò storto e proseguimmo: “Thud, thud”.
Ora sono quattro mesi che scaviamo. La roccia, sotto, si fa sempre più dura, febbraio se ne è andato e l’acqua dal pozzo esce sempre più sporca. Giallastra. Chiazzata di nero. Oleosa. E la padrona mi guarda come fosse colpa mia.
Il marito non c’è mai. E’ sempre dai vicini. Lavoro da solo al derrick e qualche volta con lei. Per ridurre i tempi morti dell’andare e venire m’ha messo a dormire in una stanzetta del sottotetto. Entro ed esco con la scala a pioli – attraverso la finestrella dell’abbaino – perché non vuole che le passi dentro casa. Non mi può vedere la padrona, ce l’ha con me. Io invece faccio il mio dovere e mi sveglio sempre avanti l’alba. Al sorgere del Primo Sole sono già ginocchia a terra – accanto alla trivella – per i ritmi sacri d’inizio lavori. Batto sul djembe piano piano – perché lei non senta – e poi attacco: “Thud, thud”.
Scavare un pozzo non è difficile. Basta far cadere una, due, infinite volte dall’alto della capra il percussore – un’asta di ferro cavo pesantissimo, con una valvola di fondo a ciabatta – finché pian piano penetra nel sottosuolo, riempiendosi di detriti. Lo risollevo per tre volte di qualche metro – a forza di mulo o di corrente, quando c’è – e lo rilascio andare: “Thud…thud…thud”, si sente dal profondo della terra. Poi lo riporto molto più in alto e lo rimollo un’altra volta – “Thud, thud, thud” – finchè non si riempie. Allora a forza di mulo faccio girare l’argano, tiro completamente fuori la sonda fino in cima al traliccio, apro la ciabatta e la svuoto. I detriti si spandono – misti all’acqua – come melma, ed io riparto: “Thud, thud, thud”, cercando di mantenere il ritmo.
Il colpo sordo dell’asta che si pianta nel fondo deve giungermi sempre alla stessa distanza di tempo: tre colpi in sequenza e poi la pausa, e tra una serie e l’altra – man mano che l’asta penetra verso il cuore della Terra – il ritmo si espande e si dilata: “Nello spazio infinito tra il battere e il levare”, diceva sempre mia madre, “si nasconde l’Eternità” e la vedo – “Hi-jack hi-jack hi-jack” – mentre canta le sue canzoni dentro la mia testa. Quando non c’è nessuno canto anch’io e qualche volta canto – ma sempre piano piano – con tre simpatici bambini che ogni tanto, dal bosco, mi vengono a trovare: “Facci una nenia” chiedono, e in cambio mi danno da aspirare degli strani ma interessantissimi tubettini di carta con della brace dentro.
“Qualche problema?!”, l’urlo di Angie mi riporta al duro mondo del reale. Non ha sentito il thud – evidentemente – quando se lo aspettava; è l’infinita versatilità del ritmo direbbe mia madre, lei mi ci controlla la produttività. Provo a sorridere farfugliando qualcosa su un meccanismo spontaneamente bloccatosi.
Lo sguardo che mi lancia chiarisce il suo pensiero.
Lascio stare il sorriso, chino il capo e a occhi bassi svuoto la sonda. Vedo però di lato i suoi stivali voltarsi e ripartire per la fattoria. Rialzo allora lo sguardo e lo fisso sul suo retroprospetto. Il dondolio delle natiche – una in alto una in basso, una in alto una in basso in battere e levare – è un ritmo nuovo ed ipnotico che spalanca mondi diversi da quelli che narrava mia madre.
Il mulo guarda anche lui e mi riguarda poi complice. Gli faccio un cenno d’assenso e reinfilo l’asta nel buco del terreno: “Thud! Thud! Thud!”
Ursula
Lì per lì non ho capito bene cosa fosse successo – aveva risposto Rooney alla chiamata – solo “una catastrofe, gli steli in pericolo, la gente che arriva in massa”.
“Ma ti sei fatto dire almeno il posto?”
“Sì, sì. A Iglesiña, da una certa Angie”.
“Angie?” e mi sono preoccupata. Solo ieri sera avevamo fatto la strada assieme e lei – al momento di lasciarci sulla Rua Juntada – ridendo aveva chiesto: “Ma davvero fai i pompini al Giudice?”
“Angie! sei scema? Credi a quella là?”
“Ah, non si può mai sapere…”, e adesso invece chissà che è successo.
Ho diramato l’allarme, disposto un blocco a Pyặvëlinskij – stavano partendo pure da Šabőtzniegorod – e ordinato che non si facesse più uscire nessuno dalla città, solo i mezzi della guardia. Non ho detto una parola nel tragitto. La gente per le strade pareva costernata. Lassie dietro guaiva. Io con la morte nel cuore: “Angie!” pensavo.
Sotto la collina grande una folla da Giorno delle Congiunzioni che ci faceva ala – muta – via via che proseguivamo nella fattoria.
Ecco le distese di mais. Laggiù i campi di steli. Ora la stalla sempre uguale, forse più piccola e malmessa. Una scala a pioli stranamente addossata all’abbaino. Anch’io – si può dire – sono cresciuta qui. Più in là c’è l’Albero dei Messaggi – alto, possente – vicino al ponticello che conduceva il bestiame al pascolo. Sotto la sua chioma prendevamo l’ombra d’estate. Sul suo tronco sono incisi i segni, le iniziali, le storie di tutte noi. C’è il mio nome vicino a quello di Seth.
Ora è tutto nero. Il cordone della guardia blocca i curiosi dietro la stalla. Gocce di pioggia fangosa mi cadono sul viso. Non è acqua. E’ melma. Oleosa. Che odora d’aspro. Gli steli per terra, avvizziti e neri. Rivoletti scuri dai filari si dirigono ai valloni.
Pare che all’inizio, dopo un piccolo boato, ci sia stato un sibilo – un “Pffffff” sempre più forte – e una nube di gas si sia sprigionata dal pozzo: “Puzzava d’uovo sodo,” dice Brainwell il musico, “il nettare della terra”. Si sente tuttora. Lui era scappato assieme al mulo, che per la paura aveva spezzato la fune. Cessato il sibilo, la nube s’era placata e loro riavvicinati. Ma un boato più grosso e dal pozzo è esplosa una colonna altissima di robaccia nera, che ha strappato e sparato in cielo il derrick – il traliccio giace ora sconvolto tra quel che resta laggiù degli steli – e la pioggia nera è ricaduta inondando i campi. Anche se assai placata, la colonna ancora getta il suo liquame tra un rumore cupo: “Broooo”.
“I miei steli, i miei steli disgraziato!” urla Angie – nera come tutti fino nei capelli – a Zacharias.
Lui è sul pozzo con Paul, i figli di Foost e il musico, a tentare di fissare alla camicia interna una saracinesca per arginare il getto. Finalmente ci riescono.
Mi avvicino. Mi inginocchio. Strofino un po’ di liquido tra l’indice e il pollice. Porto le dita al naso, poi saggio con la punta della lingua. È viscido, puzza e sa di cattivo: “Che roba è?”, chiedo al vecchio Foost.
“Petrolio, credo sia petrolio sceriffo”.
“Petrolio? Ma è un reato federale! un crimine grave proibito in tutta la galassia: Angie! sei in arresto”, urlo: “Rooney, mettile i ferri!”
“I ferri? Ma che sei scema?” urla adesso Angie: “Sono stati quei due” indicando Brainwell e Zacharias.
“Io…?” ha fatto il musico.
“I ferri! Rooney i ferri!” ho ribadito io.
“Datti una calmata” m’ha detto però piano, da dietro, il Giudice. E a Angie: “Sei a piede libero: qui è tutto sotto sequestro e tu sei il custode. Noi andiamo via, ora” ha detto poi dolce a me.
“Prendi i tuoi stracci e vai via pure tu!” ha strillato allora Angie a Zacharias: “Non ti voglio vedere mai più”. A Brainwell invece – che già s’era incamminato pure lui – ha strillato ancora più forte: “Dove cazzo vai, tu? Chi t’ha detto niente? Torna al tuo posto!” e poi, più piano, “sta pompinara…”
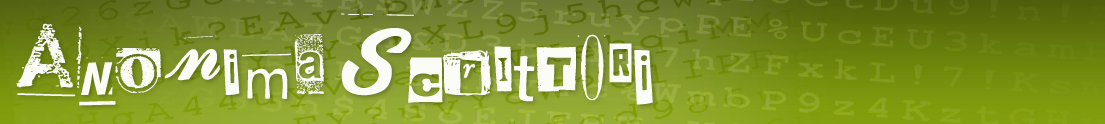

febbraio 18th, 2010 at 14:24
felice di rileggere e ricominciare
marzo 19th, 2010 at 11:57
ora rileggo.